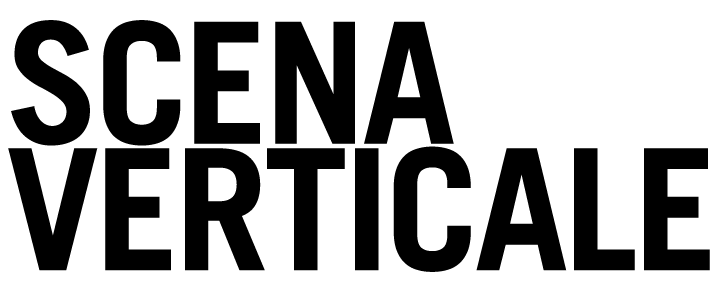La Repubblica - Anna Maria De Luca - 30/01/2026
Migrazioni, “KR70M16, naufrago senza nome”: quando il teatro restituisce dignità ai dimenticati
ROMA – KR70M16 non è solo una sigla alfanumerica. È un grido silenzioso contro l'ultimo, più crudele degli oltraggi: la negazione dell'identità. KR indica la provincia di Crotone, 70 il settantesimo corpo recuperato, M il sesso maschile, 16 l'età. Sedici anni. Un ragazzo che aveva tutta la vita davanti, ridotto a una sequenza alfanumerica in un registro di obitorio.
Non è uno spettacolo facile. Non intrattiene, ma scuote. Non distrae, coinvolge. Non lascia indifferenti. E forse è proprio questo il suo valore più grande: in un'epoca che ha normalizzato l'orrore, che ha trasformato i morti in numeri e i naufraghi in emergenza, questo lavoro ci obbliga a fermarci. A guardare. A sentire. Al Teatro India, a Roma, in prima nazionale, dal 28 gennaio al 1° febbraio, porta sulla scena una delle tragedie più laceranti del nostro tempo.
Un incontro oltre la morte. La drammaturgia di La Ruina, scritta, diretta e interpretata dall'autore stesso assieme a Dario De Luca (solo omonimo di chi scrive) e Cecilia Foti, costruisce un ponte tra epoche e tragedie. In una dimensione visionaria, quasi surreale ma sempre profondamente umana, lo spettacolo mette in scena, tra due lapidi, l'incontro impossibile tra due anime dimenticate: una vittima della migrazione clandestina e una della Shoah. Due universi di dolore che si parlano, si riconoscono, si abbracciano nell'oblio condiviso.
Il cimitero, fisso in scena, con le onde del mare come sfondo. E’ l'unico luogo dove questi fantasmi possono finalmente rivendicare ciò che gli è stato negato: un nome, una storia, una memoria. “Dietro ogni naufragio c'è un nome che non verrà mai inciso su una lapide”, spiega La Ruina. "E senza un corpo su cui piangere non ci può essere l'elaborazione del lutto, come ci insegna la struggente supplica di Priamo, re di Troia, quando chiede ad Achille la restituzione del corpo del figlio Ettore". Il bisogno di seppellire i propri morti, di dare loro dignità, è antico quanto l'umanità stessa. E oggi, nel XXI secolo, migliaia di famiglie vivono lo stesso strazio di Priamo: non sanno dove sia sepolto il figlio, il fratello, la madre. Non possono piangere su una tomba. Non possono dire addio.
La cancellazione dell'identità. "L'insulto finale è la cancellazione dell'identità", ribadisce La Ruina. Ed è proprio questa l'identità che il teatro prova a restituire. Non attraverso documenti o indagini, ma attraverso la parola, l'arte, l'empatia. Attraverso quella magia che solo il palcoscenico sa compiere: far parlare chi è stato messo a tacere per sempre.
Lo spettacolo non rinuncia all’ironia. E’ quel sorriso un po’ amaro che nasce dall'assurdo, dalla disperazione che cerca un varco di luce. Perché anche nell'orrore, la vita reclama il suo spazio. E questi naufraghi, finalmente, tornano a essere persone: con sogni, paure, desideri. Non più numeri.
Il teatro come impegno civile. In un tempo in cui il teatro viene spesso relegato a intrattenimento o decorazione culturale, KR70M16 – Naufrago senza nome, ci ricorda quale sia la sua funzione più alta: essere specchio della società, coscienza critica, luogo di elaborazione del dolore collettivo. Essere atto di resistenza contro l'oblio, contro l'indifferenza, contro la disumanizzazione. Saverio La Ruina scava nelle ferite del presente e fa domande scomode, un invito a non voltarsi dall'altra parte.
Ansa - Paolo Petroni - gennaio 2026
La Ruina, spettacolo su dignità, identità e memoria storica
''Con tutto quello che hai passato in due anni di viaggio terribile per venire in Europa e morire invece affogato quando eri quasi arrivato come è che non riesci a piangere?''.
''Proprio per quello'' è la risposta secca e pesante di Karamu, ragazzino che ha congelato i suoi sentimenti ed è il personaggio più poetico, interpretato con delicatezza e vivacità da Cecilia Foti, dell'ultimo poetico e profondo spettacolo ''Kr70M16 - Naufrago senza nome'', di e con Saverio La Ruina, in scena al Teatro India di Roma.
Karamu implora mettano il suo nome sulla lapide che segna dove è sepolto il suo corpo, al posto della sigla Kr70M16 (che indica il luogo del naufragio, il suo essere il 70 corpo recuperato, maschio di 16 anni).
Crede che solo così qualcuno leggendolo e passandolo di voce in voce lo faccia sapere a sua madre, che possa così uscire dall'incubo del limbo del non sapere più nulla di lui, come spiega al guardiano del cimitero, intenerito ma che dice di non poter mettere nomi in mancanza di documenti.
Il tema dell'identità, per coloro a cui viene negata anche dopo la morte, è quindi quello centrale dello spettacolo, con la necessità dell'elaborazione di un lutto e assieme all'assurdo voler valutare il peso delle sofferenze prescindendo da ogni senso di umanità. E' infatti il dottor Schwarz, interpretato dallo stesso La Ruina, psicanalista ebreo reduce dai campi, sepolto nello stesso cimitero, a ritenere le vittime della shoah le uniche a poter parlare di dolore assoluto e quindi irritato dal sentir dire di altre sofferenze terribili e morti innumerevoli, specie da un ragazzino per di più di colore che nulla può sapere. A convincerlo a cercar di aiutare Skaramuzzo, come lo chiama lui, a riuscire a piangere, è Dario De Luca che dà vita al guardiano del cimitero, che governa con partecipe, umana tenerezza in questo gioco lieve in bilico tra la vita e la morte.
Il valore dei morti e del far memoria storica, sempre guidata da chi ha più potere (Karamu chiede a Schwarz se conosce il genocidio degli Uti in Ruanda, di cui questi non ha mai sentito parlare) viene messo in crisi da questo testo visionario dall'allestimento essenziale, che ha la sua forza poetica anche nella trovata dell'uso del disegno dal vivo, altro materializzarsi di qualcosa che è e non è grazie sempre a De Luca (che firma anche le luci), scritto e interpretato con quello sguardo vivo, vero e ironico in cui fantasia e realtà si sorreggono a vicenda, proprio del lavoro di Saverio La Ruina che, dopo Roma, lo porterà a fine maggio a chiudere la tournée a quel suo Primavera dei Teatri di Castrovillari, che è il festival teatrale più notevole e vivo del profondo sud, dopo aver toccato Firenze il 26 febbraio, Milano dal 10 al 15 marzo, Bologna dal 18 Aprile.
Il Manifesto -Mariateresa Surianello - 14/02/26
Saverio La Ruina, rito funebre dell’umanità
Il cimitero di "KR70M16 – Naufrago senza nome", è la nuova opera dell’autore-attore-regista
Un paesaggio già frequentato da Saverio La Ruina, ma qui l’intimità del dialogo monologante con la madre sfocia nel confronto con la tragedia collettiva e senza fine dei nostri giorni. Il cimitero di KR70M16 – Naufrago senza nome, la nuova opera dell’autore-attore-regista, fresca di debutto al Teatro India, è un manifesto duro e scomodo nel suo preciso posizionamento politico. Annunciato nel titolo, l’artista calabrese crea con la sua consueta delicatezza un potente rito funebre per le migliaia di migranti dispersi nel Mediterraneo. A partire forse dall’assurdo, evitabile ed emblematico, naufragio a Steccato di Cutro, che su quella spiaggia del crotonese ha portato in pellegrinaggio decine di teatranti.
E non casuale ma per un sentire condiviso appare il rinnovato sodalizio scenico con Dario De Luca (cofondatore di Scena Verticale), perfetto officiante di questa onirica cerimonia, immersa in un biancore splendente, interrotto proprio dalle luttuose linee nere dei suoi disegni (un lettino, una poltrona, una cipolla, un brodo caldo e quell’insopportabile codice sulla lapide).
Per sé La Ruina si è cucito il ruolo del Dottor Schwarz, cinico ebreo sopravvissuto alla Shoah, anch’egli ospite senza pace del cimitero, incaricato dal Camposantaro a risolvere il problema di Karamu, il bambino ignoto africano con la pagella cucita nella giacca e la faccia rosicchiata dai pesci, bella prova per Cecilia Foti (ricorda il Pinocchio di Amleto ovvero cara mammina di venticinque anni fa), chiamata anche a cantare una ninna nanna africana e la canzone dei pescatori dello Stretto. Un terzetto efficace nella restituzione di quel filo sottile di ironia della partitura drammaturgica che col suo minimalismo distilla e dà concretezza a fatti e sentimenti. Bravo La Ruina, scontenterà molti in quest’epoca di false verità.
Paneacquaculture.net - Laura Novelli - 12/02/2026
Se morire in mare significa morire senza nome: il nuovo lavoro di Saverio La Ruina al Teatro India
Nel gennaio del 2023 Saverio La Ruina presentò al TeatroBasilica di Roma Via del Popolo, poetico affondo in una biografia personale capace di trascendere snodi esistenziali e riferimenti geografici per tradursi nella storia umana di molti. Nei giorni scorsi il ben noto drammaturgo, regista e attore calabrese è tornato sulla scena capitolina con un nuovo lavoro dal titolo KR70M16 – Naufrago senza nome, nel quale la tessitura biografica cede il passo alla cronaca e alla denuncia sociale, regalando al pubblico uno spaccato surreale, uno slittamento lirico e sulfureo che non pochi legami ha, tuttavia, proprio con il precedente spettacolo.
L’arioso palcoscenico del Teatro India (dove la pièce ha debuttato in prima nazionale) è rivestito di un biancore quasi lunare: lo abitano solo alcune lapidi molto stilizzate, atte peraltro a diventare sedie praticabili, uno sfondo che lascia presagire la presenza del mare e inserti musicali mai eccessivi (li cura Gianfranco De Franco). E lo abitano soprattutto due anime defunte, ma vive e fisicamente presenti – quella di un giovane di origine africana affogato a seguito di un naufragio di migranti (Cecilia Foti) e quella di uno psicanalista ebreo morto in un campo di concentramento (lo stesso La Ruina) – e un Camposantaro/demiurgo (Dario De Luca) che ne orchestra l’incontro, ne connette i destini e ne custodisce i rispettivi dolori.
Siamo dunque in un cimitero. Ma quel cimitero puntellato di lumini che in Via del Popolo (Premio Ubu nel 2023 come Miglior testo italiano) era soglia di memorie e di affetti parentali, qui è un luogo sospeso tra i vivi e i morti: una waste-land dalla connotazione impalpabile dove gli oggetti di scena vengono disegnati a vista e le persone scomparse sono fantasmi in carne e ossa che prendono voce per recriminare il loro sacrosanto diritto a una degna sepoltura. Che è poi il diritto di esserci, di essere riconosciuti, di avere un nome, di essere ricondotti – post mortem – all’abbraccio, al ricordo, alla preghiera di chi resta.
Se la tragedia di Cutro (era il febbraio del 2023 e morirono affogate più di 90 persone, tra cui oltre 30 minori) viene evocata dall’autore a partire proprio dal titolo, laddove la cifra KR sta ad indicare il luogo di quel terribile naufragio, è sempre nel titolo che, trascendendo quella tragedia stessa, si annida il mistero straziante, la domanda chiave del testo: chi era la settantesima vittima recuperata in mare? Aveva presumibilmente sedici anni, era maschio, ma qual era il suo nome? La sua identità?
“Certamente, tra le suggestioni che hanno ispirato KR70M16 – ci racconta lo stesso La Ruina – il dramma che si è consumato a Cutro ha avuto un ruolo nevralgico, anche se in realtà questa drammaturgia parte da più lontano. Ho iniziato a scriverne alcuni dialoghi già nel 2019, dopo aver incontrato una serie di ragazzi, ospiti di una cooperativa di Catania, che avevano alle spalle viaggi disperati e che mi hanno raccontato aneddoti sconvolgenti. In quell’anno stavo facendo una ricerca sulla religione islamica e mi sono improvvisamente ritrovato immerso in vicende umane alle quali sentivo di dovermi avvicinare con maggiore forza. A quel primo nucleo di materiali si sono poi aggiunti altri cruciali motivi di ispirazione: quanto avvenuto a Cutro, con tutto quello stuolo di bare bianche, le migliaia di persone affogate nel Canale di Sicilia e soprattutto gli studi della professoressa Cristina Cattaneo, un’eccellente anatomopatologa che lavora da decenni per dare un’identità ai cadaveri di migranti e per permettere ai loro cari di elaborare il lutto (suo il saggio Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Raffaello Cortina Editore, 2018, ndr). Proprio a lei devo il personaggio di Kamaru, un ragazzino con il volto mangiato dai pesci che muore in mare senza un nome e che viene ritrovato con la pagella scolastica cucita dentro il giubbotto, come a voler mostrare che era bravo e che meritava accoglienza qui da noi”.
Pantaloni corti e – appunto – giubbotto sportivo verde, il giovane Kamaru di Ceclia Foti (molto incisiva nel caratterizzare la levità e insieme l’accorato bisogno di aiuto del suo personaggio) ha tutto l’ingenuo candore dei suoi anni, ma possiede anche una saggezza adulta, votata a interrogarsi e interrogarci sul senso e sul peso della sua morte. Kamaru chiede dignità; si lamenta che sulla sua lapide non ci sia scritto il suo nome, costantemente storpiato dal docile Camposantaro (un ottimo De Luca, pacato e paterno, qui anche curatore del disegno luci e delle illustrazioni) nel più italiota Skaramuzzo. Ma il ragazzo non ci sta, insiste che per lui – cadavere senza documenti nel cimitero del Mediterraneo – è importante e, quando il Camposantaro gli chiede casa cambi se c’è il suo nome oppure no, la risposta non ammette repliche: «Cambia, perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome ne parlerà con qualcun altro che ne parlerà con qualcun altro ancora, fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre».
È pertanto nel cuore di quella pietas antica che ci lega ai sentimenti imprescindibili che va rintracciato il grumo ostinatamente umano di questo bel lavoro: il pensiero va al vecchio Priamo che si umilia di fronte ad Achille chiedendogli il corpo martoriato di Ettore; ma il pensiero va anche, e soprattutto, ai celebri versi con cui Ugo Foscolo connette la perdita di un figlio proprio al dolore di una madre: «Questo di tanta speme oggi mi resta! / Straniere genti, l’ossa mie rendete / allora al petto della madre mesta». Non sapremo mai se la richiesta di Kamaru – e quella dei tanti “innominabili”colpiti dallo stesso destino – abbia trovato ascolto. Ma, per quanto tale richiesta ci chiami in causa come esseri umani a una presa di coscienza necessaria, forse non è “solo” questo il punto. E non lo è perché la pièce di La Ruina – sorretta da una scrittura asciutta, quasi beckettiana, originale, ironica ed estremamente delicata – va oltre; aziona, cioè, un meccanismo drammaturgico sghembo e teatralissimo, pur nella sua semplicità, che parte dalla ricerca identitaria del protagonista per innescare un incontro di anime e offrirci una più ampia riflessione sulla Morte, sulla Storia, sul Lutto e sulla Memoria.
Complice l’interessamento del bonario Camposantaro, il giovane migrante conosce infatti uno psicologo austriaco morto durante l’Olocausto e ospite dello stesso cimitero, il dottor Schwarz, che dovrebbe aiutarlo a mitigare la sua crisi identitaria e con cui imbastisce una conversazione conflittuale ma in fin dei conti tenera, per quanto dolorosa. Gesti cauti, ritmo della voce cadenzato, registri sottoesposti e, anche qui, inscritti in una vocazione a togliere che ben intercetta l’essenzialità della scrittura e della regia, l’autore interpreta l’elegante medico – in completo bianco e gilet dai toni dorati – con estrema sensibilità, rendendolo una figura ruvida e dolce insieme, un simbolo di quella supremazia del dolore bianco – «Ma sai con chi stai parlando? Noi siamo morti a milioni, bruciati nei forni crematori, non c’è sofferenza più grande, va bene?» – che purtroppo l’abominio di Gaza ha evidenziato con spietatezza ingiustificabile.
“Anche questo personaggio – riprende La Ruina , raggiunto telefonicamente a Parigi in occasione di una ripresa di Dissonorata all’Istituto Italiano di Cultura per celebrarne i vent’anni dal debutto – lo avevo in mente sin dal 2019 ed è ispirato ad una persona realmente vissuta. Il dottor Schwalz era un medico ebreo austriaco che stava a Castrovillari tanti anni fa e che mi curò quando ebbi un incidente con la moto. Mi ricordava tanto Freud, era stato internato in un campo e tutti in paese lo chiamavano Scivalzo”.
Le luci si abbassano e virano verso il blu. L’incontro tra il giovane con il volto morso dai pesci e l’anziano dottore che ha vissuto l’orrore del lager merita compostezza ma rimane lieve, persino divertito, e accarezza l’umanità di entrambi: ombre di una Spoon River che ci comprende tutti. C’è un afflato spirituale intenso. Karamu dice di andare dalla madre ogni notte e di sentirla piangere. Anche Schwarz rievoca la madre, una lettera drammatica, uno strappo impossibile da cucire. E allora ecco che il dolore di ciascuno non cede più ad alcuna differenza. È dolore e basta. E questo sì che ci riguarda da vicino. Forse basterebbe ammorbidire le nostre anime. Capire che il cimitero più sacro è sempre dentro di noi e dentro gli altri. «Ma nel cuore / nessuna croce manca/ È il mio cuore / il paese più straziato», ha scritto Ungaretti. Basterebbe capire e sentire che, semplicemente, le tragedie degli altri sono anche le nostre tragedie e che non esistono sacrifici più nobili di altri. Non a caso, nell’epilogo delle piéce, l’anziano psicoterapeuta immagina di cadere in mare con il ragazzo e di vivere ciò che lui ha vissuto. Un viaggio tra oggetti, giocattoli, abiti, quaderni e «fiumi di indirizzi». Quando riemerge in superficie, si alza e scrive “Karamu” sulla lapide. Un gesto pietoso, poetico, che, nella sua bellezza quasi ingenua, suona come un monito, una denuncia acre. Perché anche la poesia può scendere in battaglia a teatro.
Avvenire di Calabria - Davide Imeneo - 30/01/2026
La tragedia di Cutro in scena al Teatro India: Saverio La Ruina dà voce alle vittime senza nome del mediterraneo
L’arte drammatica incontra la cronaca più dolorosa per restituire umanità a chi è stato ridotto a un numero di protocollo. La tragedia di Cutro, che ha segnato profondamente la coscienza collettiva non solo calabrese ma dell’intero Paese, trova una nuova narrazione attraverso il teatro di Saverio La Ruina. L’attore e regista calabrese porta in scena il dramma dell’anonimato post-mortem, esplorando il limbo burocratico e spirituale di chi perde la vita in mare senza lasciare documenti, ma solo un corpo da catalogare. Attraverso la storia di un singolo codice alfanumerico, l’opera indaga il diritto al nome e la necessità del lutto per chi resta, trasformando i dati freddi dei fascicoli forensi in un dialogo toccante tra il mondo dei vivi e quello dei morti, dove la richiesta di identità diventa l’ultimo, disperato atto di esistenza.
Il codice diventato carne
Un codice alfanumerico può contenere una vita, un’infanzia, una speranza, un viaggio e la sua tragica interruzione. Al Teatro India di Roma, la sera del 28 gennaio, quel codice è diventato carne e voce grazie a Saverio La Ruina: l’opera teatrale “KR70M16 – Naufrago senza nome” è un tentativo disperato e poetico di restituire dignità a chi è stato ridotto a un fascicolo forense dopo la tragedia di Cutro. La scena si apre su una dimensione sospesa, un cimitero che pare un limbo, dove il dialogo tra un custode, figura rigida e burocratica, e l’anima di un ragazzo, che rivendica la propria identità, svela l’orrore dell’anonimato.
La burocrazia della morte
Il protagonista non accetta di essere quel KR70M16 inciso sulla lapide, lui ha un nome, Caramù, e lo ripete ossessivamente, scontrandosi con il muro di gomma di chi gestisce la morte come un lavoro, una pratica da sbrigare nel più breve tempo possibile. Il custode, trincerato dietro l’assenza di documenti, rifiuta di incidere quel nome sul marmo: «Com’è che qua non c’è scritto niente?», chiede il ragazzo. «Il nome, ci dovrebbe essere scritto il nome». La risposta dell’addetto è gelida, logica secondo i parametri di un mondo che ha smesso di guardare in faccia le persone: «Ci vogliono i documenti». Senza quel pezzo di carta, per il mondo dei vivi e per l’archivio dei morti, Caramù resta un numero progressivo, maschio, di età presunta sedici anni.
Il diritto al lutto
Il dramma si consuma tutto nella necessità di far sapere a una madre che il figlio non tornerà. Non per crudeltà, ma per concederle il diritto al lutto, per interrompere quell’attesa straziante che non ha fine. «Se non mi ha davanti non avrà la certezza che sono morto», spiega il ragazzo al custode, che cinicamente suggerisce come l’incertezza lasci spazio alla speranza. Ma Caramù sa che quella speranza è una condanna: «Ma così non avrà mai pace! Lo so, lo so… ci vado ogni notte da lei. La sento che si dispera perché non sa che fine ho fatto». È la richiesta di una tomba su cui piangere, l’atto di pietà più antico del mondo che viene negato dalla mancanza di riconoscimento.
Il caos della fine
Il momento più toccante e paradossale dell’opera arriva quando il naufrago ripercorre gli istanti della fine, immaginando una morte “ordinata” che avrebbe potuto salvare la memoria, se non la vita. Caramù teorizza una disciplina del morire, impossibile e straziante, contrapposta al panico reale. Racconta come, se ci fosse stato silenzio, i naufraghi avrebbero potuto gridare il proprio nome uno alla volta, permettendo ai sopravvissuti di memorizzarli in una catena umana di testimonianza. «Arriva un’onda di sette metri, mi butta fuori dalla barca, e io prima di finire sotto grido il mio nome: “Caramù!”», immagina il protagonista. «Gli altri, quelli che sono ancora sulla barca, stanno zitti, concentrati, lo sentono, lo memorizzano».
Un atto di restituzione
La realtà, però, è stata diversa, e La Ruina ce la restituisce con una crudezza che non lascia scampo allo spettatore seduto in platea: non c’è stato nessun ordine, nessuna catena di salvataggio della memoria. In quel mare in tempesta «gridavano tutti insieme», confessa il ragazzo, «un fracasso di nomi che non si capivano». Quella confusione ha inghiottito le identità prima ancora dei corpi, lasciando i nomi in gola alle vittime e consegnando alla storia solo una serie di sigle fredde come l’acqua di febbraio. Saverio La Ruina, con questo lavoro prodotto da Scena Verticale, compie dunque un atto di restituzione: dove la cronaca ha registrato numeri, il teatro ha provato, per una sera, a urlare quei nomi rimasti inascoltati.
Gazzetta del Sud - Elisabetta Reale - 08/02/2026
Il dolore di ogni vittima è tutto il dolore del mondo. «Kr70M16», il nuovo spettacolo di Saverio La Ruina
In un cimitero s’incontrano loro, i sommersi, i dispersi, gli sconfitti dalla Storia. E sono uguali, e sono unici
Una tomba senza nome in un cimitero che sembra essere sospeso fra terra, mare e cielo. E anime in attesa di ritrovare un nome e con esso la dignità di essere ricordate, nella morte, per superare tutto il dolore e le atrocità della vita. Si muove leggero e intenso l’ultimo lavoro scritto, diretto e interpretato da Saverio La Ruina, artista calabrese di Castrovillari, che al Teatro India di Roma ha debuttato con «Kr70M16 - Naufrago senza nome», prodotto da Scena Verticale. Con lui, in scena, Dario De Luca – con La Ruina, altra anima della compagnia, realtà viva e vitale nel panorama teatrale italiano –, e l’attrice e cantante messinese Cecilia Foti, a dare vita ad uno spettacolo che parla di memoria e dignità, di identità cercata e negata, del rapporto con la morte e con la salvezza in un tempo in cui la vita troppo spesso è segnata da violenza e atrocità, ma anche dell’amore puro e incondizionato fra una madre e un figlio.
Attraverso una narrazione lieve e al contempo tragica, fatta di immagini soffuse, tempi dilatati che scavano nei ricordi del passato e intrecciano i fili della vita come della morte, impreziosita da musiche ora soffuse ora ritmate (di Gianfranco De Franco), La Ruina imbastisce un racconto che prende le mosse proprio da un cimitero, luogo dove spesso i testi del drammaturgo calabrese – il cui pluripremiato monologo «Dissonorata», che compie vent’anni, proprio in questi giorni è in scena alla Comédie-Française – approdano, per dipanarsi nelle pieghe più intime e profonde della vita.
Fra le tombe senza nome incontriamo Karamu, interpretato con grazia e profondità da Cecilia Foti, ragazzino senegalese che ha perso la vita in mare nel tentativo di trovare un futuro migliore. Karamu non si rassegna all’essere solo una sigla, quel KR70M16 che sta a significare il luogo del ritrovamento, le spiagge di Crotone, il numero della salma, il sesso e l’età. Lui, nei suoi abiti scelti con cura dalla madre, per ben presentarsi alla nuova vita, non vuole essere solo un numero, ma una persona, è un naufrago senza nome che rivendica con ostinazione la propria biografia e chiede di «essere» perché solo così, forse, la madre può venire a conoscenza della sua morte. Storie di ordinaria disumanità, vite spezzate dal mare che diventa buco nero di sogni e speranze.
Esistenze che vengono accolte dal guardiano del cimitero, l’unico vivo fra i morti, nell’interpretazione ricca di sfumature di Dario De Luca (che firma anche le luci), che bene si muove nella terra di mezzo – ricordiamo il suo intenso «Psicopompo», spettacolo di cui è autore, regista e interprete, dove proprio il tema della morte e del fine vita diventano assoluti protagonisti – umanissimo e diretto, nel provare a dare pace alle anime dei vivi così come dei morti. Il triangolo si chiude con la figura, fredda e distaccata, del dottor Schwarz, interpretato dallo stesso La Ruina, psicanalista ebreo imprigionato nel campo calabrese di Ferramonti che ha poi deciso di vivere la propria vita a Castrovillari e di cui La Ruina ci aveva già detto nel suo «Via del popolo», spettacolo incentrato proprio sul recupero della memoria dei luoghi a lui più cari.
Sono fili che s’intrecciano fino a scontrarsi quelli imbastiti con delicata sapienza da La Ruina, che affondano nelle ferite del nostro tempo: il dramma dei migranti e dei popoli senza pace, in Africa, come in Palestina. Figura emblematica quella del dottor Schwarz, medico rancoroso e solo in apparenza privo di sensibilità verso il dolore degli altri, convinto che solo il proprio – e quello del popolo ebreo vittima delle atrocità della Shoah – meriti di essere considerato e guardato con compassione. Ma non può esserci primato nel dolore, nelle sofferenze, nella dignità violata e, senza buonismo di sorta o falsa retorica, la parabola umanissima messa in scena da La Ruina ci ricorda proprio questo e ci invita a considerare l’altro, chiunque esso sia, come portatore di uguale dolore e di uguale dignità e a chiamarlo con il proprio nome.
Dopo il debutto romano, altre tappe attendono «Kr70M16 - Naufrago senza nome»: Firenze il 26 febbraio, Milano dal 10 al 15 marzo, Bologna dal 18 aprile per approdare infine, a maggio al festival Primavera dei Teatri di Castrovillari.
Avvenire - Michele Sciancalepore - 04/02/2026
In un cimitero di lapidi anonime, un ragazzo africano di sedici anni si confronta con un psicoanalista vittima della Shoah. Una riflessione sull’elaborazione del lutto
La spoon river dei sommersi
In “KR70M16”, Saverio La Ruina porta in scena, con leggerezza tragica, le storie sospese di chi è negato nel Mediterraneo restando privo del suo nome.
“KR70M16” non è il numero di un biglietto della lotteria Italia e non è la targa di un’automobile. È il freddo e arido codice burocratico che serve a identificare un naufrago senza nome. “KR” sta per Crotone, il luogo del naufragio; “70” indica che è il settantesimo corpo ritrovato; “M” designa il genere maschile; “16” l’età presumibile. E così la burocrazia l’abbiamo sistemata, per nulla la coscienza, pur mettendola a tacere. Chi la ascolta e la fa parlare senza urla roboanti, né virulente denunce ma con straniante e singolare amara dolcezza è Saverio La Ruina, con il suo ultimo lavoro (prodotto da Scena Verticale e presentato in prima nazionale a Teatro India di Roma, prossima tappa il 26 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, poi Milano, Bologna e a maggio al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari), dal titolo per l’appunto KR70M16 – Naufrago senza nome.
Sulle tragedie del mare si è steso ormai da tempo un velo pietoso, una spessa coltre di anestetica assuefazione che ogni tanto il teatro tenta di squarciare. Ricordiamo L’Abisso, di Davide Enia, sulle deliranti imprese dei “rescue swimmer”, gli eroici soccorritori marittimi, o il più recente e pluripremiato A place of safety dei Kepler-452, testimoni della missione di salvataggio a bordo della Sea-Watch.
La Ruina sceglie invece coraggiosamente un registro poco esplorato e ardito, quello di un’apparente soavità, coprendo con un manto un po’ scanzonato, rarefatto e ovattato, le atrocità sommerse, che quando riaffiorano lasciano segni indelebili.
Siamo in un cimitero, ma non c’è marmorea concretezza, è piuttosto un luogo etereo, sospeso nel tempo e nell’immaginazione, un iperuranio in cui i vivi e i morti si confondono e le cose sono dematerializzate, a partire dalle lapidi che, come qualunque altro elemento scenico, dai suppellettili ai cibi, grazie a una felicissima e originale idea drammaturgica, sono solo disegnate e stilizzate con tratti chiari e lampanti in tempo reale.
In questo onirico e cimiteriale ambiente, come nell’antologia di Spoon River, si animano fantasmagoriche presenze che però, a differenza del poema di Edgar Lee Masters, “non dormono sulla collina”, ma si danno da fare: KR70M16, il sedicenne “naufrago senza nome”, che dichiara subito con fanciullesca ostinazione (perfetta e senza cliché Cecilia Foti nei panni dell’adolescente) l’impellente desiderio di vedere il suo vero nome, Karamu, scritto sulla lapide al posto dell’anonimo codice affinché sua madre possa finalmente avere un posto per piangerlo; il “campo santaro” (un serafico Dario De Luca, anche artefice dei disegni), che cerca di aggirare le rigide e asfittiche maglie burocratiche per accontentare il ragazzo; infine, il dottor Schwarz (il personaggio più spigoloso e problematico reso credibile dallo stesso Saverio La Ruina), uno psicanalista vittima della Shoah a cui viene chiesto di aiutare Karamu a vincere il suo blocco emotivo per poter versare lacrime liberatorie.
In questo sviluppo onirico, dipanato a tratti in modo dilatato e compassato, emergono chiaramente un paio di tematiche: la necessità dell’elaborazione del lutto e il bisogno urgente di un’identità formalizzata, di un nome vero e non di un codice astratto per esistere nella memoria di chi resta, perché, come scriveva Cesare Pavese, “l’uomo mortale non ha che questo di immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia”.
C’è però un altro tema che serpeggia: il confronto tra due tragedie lontane nel tempo, l’Olocausto e le catacombe dei morti in mare. Si profila “una sfida a chi ha sofferto di più”, che vede il dottor Schwarz rivendicare il primato e il monopolio della sofferenza con evidenti echi delle attuali polemiche sull’opportunità dell’uso del termine genocidio per i morti di Gaza.
In realtà, La Ruina aveva concepito questa riflessione in tempi non sospetti: “Ho scritto questo dialogo nel 2019 – ci confida il regista e drammaturgo calabrese – ma il fatto è che noi occidentali conosciamo molto bene le sofferenze che ci riguardano da vicino, ma siamo molto poco interessati a capire quelle lontano da noi. I media, ad esempio, si precipitano nel ricostruire le storie private delle vittime dei drammi che ci capitano, ma non si sono mai preoccupati di cercare di dare un nome a chi ha perso la vita nel mare. Ho assistito alla discesa a Lampedusa o a Cutro di parenti dalla Svezia, dalla Germania, dalla Francia e dalla stessa Italia per riconoscere i loro cari, perché ne avevano un bisogno imprescindibile. Quando la morte colpisce noi occidentali, la macchina dell'elaborazione del lutto è molto oliata ed efficace. Non accade la stessa cosa per le tragedie nel Mediterraneo. Il grado di civiltà, sensibilità e premura che sembra così alto nei confronti di sofferenze che sentiamo nostre, si assopisce o svanisce del tutto nei confronti di quelle dei migranti”.
Anche quando La Ruina ci svela la genesi del suo lavoro, emergono aspetti sconcertanti: “La scintilla è stata la lettura di un evento raccontato da Cristina Cattaneo in Naufraghi senza volto. Lei è una anatomopatologa che racconta del corpo di un giovane con indosso un giubbotto all'interno del quale aveva cucito una pagella con ottimi voti. Sua madre ci teneva che la portasse con sé perché per lei quello poteva essere il modo migliore per presentarsi in Occidente. Tutto ciò fa tenerezza, ma fa anche molto male perché riflette la convinzione che l'Europa non accoglie chi soffre e ha bisogno, ma soprattutto solo chi ha buone “referenze”.
Sono trascorsi 13 anni dagli appelli di Papa Francesco a Lampedusa contro la “globalizzazione dell'indifferenza”. Otto secoli dalla famosa “Carta Manden” del Mali, in cui si formalizzava la legge del mare: “Ogni volta è una vita. Ogni vita vale”. Più di 2.000 anni dall'invito evangelico ad accogliere il “forestiero”. Ma oggi si parla di “remigrazione”. Per Saverio La Ruina una vera stortura: “A chi mi dice perché non accolgo i migranti a casa mia, rispondo che casa mia è aperta. Capisco che chi vive in periferia vede inevitabilmente l'immigrazione come un pericolo. Ovviamente l'accoglienza va gestita. Ci vuole un processo di integrazione e capisco chi teme il flusso migratorio perché vive già in condizioni, in un contesto sociale difficile. Capisco meno chi vive nella sua bolla abbiente”.
Parole spiazzanti, quelle dell'autore e regista, che anche sul palcoscenico, sotto quella leggerezza formale, fa affiorare punte di strazio e dolore: “Prima di annegare, si grida il proprio nome, gli altri stanno zitti, lo memorizzano e poi fanno il passaparola”. E nello struggente monologo finale di Karamu, si precipita dal gioioso disneyano refrain “In fondo al mar”, con le profondità che sembrano un parco giochi con tricicli, orsacchiotti e Topo Gigio, all'horror vacui di un abisso disumano e senza vita: “Ma i bambini? Dove sono i bambini?”