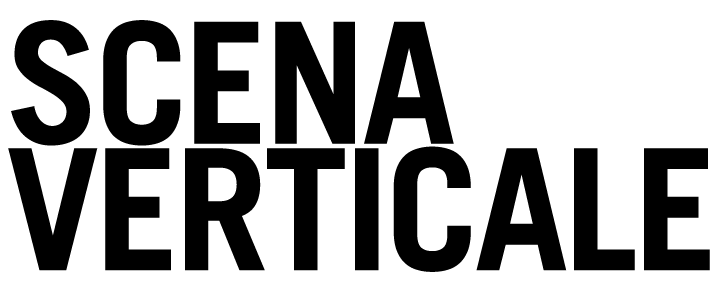Scena Verticale
Gazzetta del Sud Online - Vincenzo Bonaventura - 06/02/2025
Di e con Dario De Luca, prodotto dalla compagnia di Castrovillari, a nove anni dal suo debutto è ripartito dal Teatro Oscar di Milano in una versione aggiornata
Realistico ma anche evocativo e struggente, fortemente emotivo, come un grido sussurrato che risuona assordante più nella mente e nel cuore che non nell’udito, pure spiazzante per il rapporto inconsueto che propone tra malattia e sacerdozio, tra vocazione e perdita dei rapporti con la realtà. È tutto questo il pluripremiato «Il Vangelo secondo Antonio» di e con Dario De Luca, prodotto da Scena Verticale di Castrovillari, che a nove anni dal suo debutto è ripartito dal Teatro Oscar di Milano in una versione aggiornata.
Il morbo di Alzheimer, con tutti gli sconvolgimenti che porta nella vita non più vita piena di chi ne è colpito e ancor di più nell’esistenza di chi si prende cura del malato, è il vero protagonista del lavoro e in qualche maniera si può dire che i tre personaggi siano al suo “servizio”.
Don Antonio, parroco di Bivongi (Reggio Calabria) e vicario del vescovo, è un attivissimo sacerdote, completamente dedito alla sua missione religiosa, aiutato dalla sorella-perpetua Dina e dal diacono Fiore. Sembra che nulla e nessuno possano fermarlo finché la malattia irrompe nelle sue giornate, prima condizionandolo e poi portandolo nel vuoto di una mente che vaga senza avere più punti di riferimento.
De Luca, che si è avvalso della collaborazione di esperti di neurogenetica, ricostruisce in scena tutti questi passaggi: dai primi inciampi alla fase in cui il protagonista ha la coscienza del male che lo ha colpito fino al progressivo decadimento che lo avvilisce nel fisico e lo confina in un mondo mentale tutto suo. In questo crescendo (ma forse sarebbe meglio dire decrescendo) l’autore inserisce l’assoluta originalità di vedere come un prete può affrontare la situazione di degrado del pensiero e delle azioni.
Don Antonio crea a poco a poco un suo personale rapporto con il Cristo crocifisso (scultura realizzata da Sergio Gambino). Si chiede cosa abbia fatto questo giovane per meritare una punizione così tremenda e perché sia nudo (e vuole una coperta per coprirlo), vorrebbe riscrivere questa parte della storia e dei vangeli. Il Crocifisso diventa per il malato un oggetto feticcio, fino a creare una zona di assoluta ambiguità tra fede spontanea e insegnamenti catechistici, spunto per un percorso che, laico e credente che sia, ciascun spettatore ha la possibilità di fare: «Il Vangelo secondo Antonio» può diventare anche il Vangelo secondo ciascuno di noi. D’altra parte, lo spettacolo propone anche altri e vari spunti, una sequenza di suggerimenti che, pur rimanendo sullo sfondo rispetto alla trama principale (per esempio, i naufragi dei migranti sulle coste calabresi), allargano i temi contemporanei e quindi le occasioni di riflessione per gli spettatori (non a caso a lungo plaudenti alla fine).
Con un’intensità interpretativa che si modula a ogni passo della vicenda, Dario De Luca è un don Antonio che si sfalda sotto i nostri occhi e penetra cuori e coscienze. La catanese Matilde Piana, la sorella del prete, non gli è da meno e tratteggia in maniera perfetta e significativa il dramma di chi accudisce un malato di Alzheimer, tra affetto, rabbia e disperazione. Davide Fasano, nei panni del diacono che poi succede al parroco, è un degno comprimario.
Paneacquaculture.net - GIORGIA VALERI - 21 febbraio 2025
Postulati di fede e assiomi di demenza nella fede secondo Dario De Luca
Per dogma si intendono tutte quelle verità definite, indiscutibili e universali, accettate come vere senza bisogno di dimostrazioni o ulteriori prove perché autoevidenti. Si tratta in sostanza di qualcosa di rivelato o comunque imposto dall’alto, che come tale viene accettato: “Maria è sempre vergine, prima, durante e dopo il parto di Gesù Cristo”.
Per assioma si intende invece un enunciato che, sebbene non dimostrabile, è posto alla base di sistemi formalizzati, garantendone la coerenza. Sono quindi proposizioni primitive, evidenze vere fino a prova contraria, né immutabili né assolute, come quelli della geometria euclidea. “Tra due punti distinti del piano passa una e una sola retta”, per intenderci.
Un cavillo linguistico che per svariati secoli la Chiesa usò a suo favore come spauracchio contro tutti gli oppositori, ponendo gli assiomi della fede come dogmi. Uno su tutti: Giordano Bruno, il filosofo napoletano che osò sfidare i teologi cinquecenteschi asserendo l’esistenza di infiniti mondi e l’immanenza di Dio. Eresia assoluta che comportò il suo immediato rogo.
I dogmi, a differenza degli assiomi, non prevedono il principio di provvisorietà: non sono ammesse riformulazioni o revisioni. Vanno ripetuti a menadito per incastonarsi nel bagaglio della memoria a lungo termine.
Ma.
Ma se, da adulti, si accumulano strutture proteiche anormali nel cervello tali da interferire con la comunicazione tra i neuroni, questi ultimi perdono la loro funzione e alla fine muoiono; se la rete neuronale si disgrega tutte le informazioni accumulate si disperdono e spariscono.
Cosa succede quindi alla fede, ai dogmi religiosi, e infine, all’identità personale, se si viene colpiti da una malattia degenerativa come l’Alzheimer?
Si può divorare un’intera ciotola di ostie benedette, anziché distribuirle tra i presenti. Oppure spostare tutte le statue di una parrocchia per paura che scappino via. O chiedersi perché un ragazzo innocente è appeso tutto nudo a una croce di legno.
Dario De Luca poteva scegliere un grosso politico, uno di quelli ingombranti e che gravita nei piani più alti del Senato, per capire come la demenza modifichi radicalmente la struttura della realtà. Eppure il regista, attore, drammaturgo calabrese, fondatore, insieme a Salvatore La Ruina, della compagnia Scena Verticale ha capito che la politica genera divisione, non produce empatia.
Avrebbe posto gli accenti sbagliati su vicende che evocano invece un mondo di delicatezza, dolcezza, poesia e dolore. Così il regista ha affidato il binomio antinomico di memoria e fede alle vicende di un parroco delle periferie italiane, vicario del Vescovo e impegnato nella lotta umanitaria per la salvaguardia dei migranti sbarcati sulle coste calabresi.
Il Vangelo secondo Antonio, uno spettacolo in scena dal 2016 e che da allora ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio per la migliore regia e drammaturgia Tragos, nasce proprio dalla ricerca intorno alla demenza, a tutte quelle malattie della mente che intaccano la struttura cerebrale e la disintegrano. Con tutte le conseguenze del caso. Il successo che accompagna lo spettacolo da oltre nove anni è dato da un sapiente dosaggio di elementi performativi e drammaturgici che si avvalgono innanzitutto di una struttura classica, tradizionale, per scandagliare un argomento considerato tutt’oggi un tabù inaffrontabile, anche dal teatro contemporaneo. Se di sociale si parla, è giusto che il teatro vada a fondo anche nelle esperienze più dolorose dell’uomo, anche quelle intimistiche e che non hanno un impatto politico. Almeno apparentemente.
E così De Luca, interprete del protagonista Antonio, mescola ricerche sul campo, denuncia sociale e una buona dose d’ironia per raccontare tragedie quotidiane, che si consumano nell’intimità delle case. Si serve di una scenografia scarna, essenziale: una grande struttura di ferro, stilizzazione di una sagrestia, che si illumina a seconda della stanza di riferimento delle varie scene. Dietro, un altare in penombra, sormontato da un pesante crocifisso di legno, novità di produzione, dal momento che inizialmente De Luca aveva optato per la costruzione di una scenografia realistica, presto sfrondata per dare maggiore ariosità al complesso scenografico e testuale.
E come intuizione è giusta: lo spettacolo si muove in direzione della perdita, della decostruzione del linguaggio e delle idee. È una sottrazione del pensiero non operata solo dal protagonista Antonio, che da parroco di provincia attivo fino all’esasperazione per la comunità arriva ad essere completamente non autosufficiente, ma anche degli altri due personaggi che gli gravitano attorno: la sorella e perpetua Dina, che è costretta ad abbandonare le resistenze nei confronti della malattia, ma anche del dolce e giovane diacono Fiore, che da braccio destro e instancabile aiutante di Antonio coglie l’occasione per accaparrarsi il suo posto.
I dialoghi tra i tre sono asciutti, concisi, ben ritmati e sostenuti da azioni sceniche ragionate: se nelle prime scene Antonio cerca le scarpe per donarle ai bisognosi, nelle ultime non sa neanche più di che oggetto si tratti né tantomeno che scopo abbiano. Non c’è mai infatti una vera e propria diagnosi di demenza, ma uno snodarsi di gesti, che da quotidiani diventano straordinari, in un’operazione di destrutturazione del gesto abituale. Se quindi la prima avvisaglia della malattia è data da Antonio che mette i calzini nelle mani anziché ai piedi, in ultima battuta, diventano i guanti per proteggere le braccia del crocifisso dal freddo. La potenza espressiva di De Luca, insieme a quella di Matilde Pianae, seppur meno incisiva, di Davide Fasano, racconta tutto il non detto, il sottotesto omesso che arriva allo spettatore in modo diretto.
È uno spettacolo, quello di De Luca, che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo, con qualche ammiccamento anche se misurato, che non ricorre a grossi espedienti stilistici, testuali o avanguardistici per farsi portavoce di una sofferenza universale, indirizzata più ai parenti dei malati di Alzheimer che ai malati stessi.
Sebbene la spiritualità, cattolica in questo caso, poteva essere bersaglio di feroce critica o strumento di facile “proselitismo”, De Luca è abile nell’utilizzarla come espediente per raccontare visivamente una malattie invisibile, silenziosa, svincolandosi da ogni tipo di etichetta e giudizio. L’assioma finale è quello dell’affetto, universale e condiviso, privo di margini e confini, pure nell’orizzonte limitato della malattia mentale e dello spazio conciso di un sagrato di periferia calabrese.
Teatro Oscar DeSidera, Milano | 1 febbraio 2025
Delteatro.it – Renato Palazzi – 03/12/2016
Vorrei rendere teatralmente giustizia a Dario De Luca, co-fondatore con Saverio La Ruina del gruppo Scena Verticale, il cui nuovo spettacolo, Il Vangelo secondo Antonio, è stato piuttosto maltrattato all’ultima edizione del festival Primavera dei Teatri, forse anche a causa di un impianto scenografico che spostava l’intera azione verso un’impostazione troppo realistica. Non ero presente a Castrovillari, e non posso quindi giudicare ciò che si vide in quell’occasione: ma la proposta cui ho assistito al Teatro Ringhiera di Milano mi è parsa avere un impatto del tutto diverso. Mutata quell’ambientazione, evidentemente condizionante, a favore di un apparato visivo molto più scarno ed essenziale, un’agile struttura metallica contornata di led che si accendono e si spengono secondo necessità, conferendo alla vicenda una risonanza tutta interiore, per certi versi quasi astratta, si evidenzia ciò che era insito fin dall’inizio nella natura di questa esperienza: che non si tratta cioè della mera rappresentazione delle conseguenze dell’Alzheimer da cui è colpito un prete di provincia, ma di un caso emblematico, che suscita interrogativi ben più inquieti su ciò che resta della spiritualità quando essa viene minata da un declino fisico e intellettuale. Personalmente, da non credente, mi ha turbato l’immagine di questo parroco di un paese calabrese che, dopo essersi prodigato per l’intera sua vita nei confronti degli altri, degli umili, dei bisognosi, degli immigrati che approdano di continuo su quelle coste, si trova in breve tempo a non ricordare più nulla della sua missione, a ingurgitare avidamente ostie consacrate, a chiedere chi sia quel giovane inchiodato alla croce che campeggia sullo sfondo, e cosa abbia fatto di male per meritare una simile punizione. Dietro al minuzioso studio dei sintomi e degli effetti di questa crudele malattia, che fiacca la resistenza non di chi ne è affetto, ma di chi gli sta intorno – come dice la sorella-perpetua di don Antonio, sollevando qualche dubbio sui naturali limiti della pietà cristiana o anche solo della compassione famigliare – si avvertono abissi ben più vasti: si coglie il vuoto che viene aperto dal venir meno del sotterraneo ma sostanziale rapporto fra fede e ragione, spicca il contrasto fra l’insanabile debolezza dell’umano e l’ideale, alta purezza del sacro. Storicamente, in fondo, abbiamo avuto in questi anni due papi uno dei quali invocava la morte per alleviare le sofferenze fisiche, e un altro si è dimesso ritenendo di non avere più le forze per assolvere al proprio incarico. Questa caduta viene raffigurata con un’intensità persino dolorosa. Ho però l’impressione che resti come sospesa. De Luca, molto bravo nell’evocare gli smarrimenti, le allucinazioni di Don Antonio – così come bravi sono gli altri due attori, Matilde Piana e Davide Fasano nei panni rispettivamente della sorella e del giovane diacono – al culmine della sua discesa nei meandri della patologia sembra fermarsi alle soglie di un estremo paradosso: nel suo buio mentale, il sacerdote si tiene avvinghiato alla propria coscienza religiosa attraverso un rapporto istintivo, viscerale col corpo del Cristo, che stacca dalla croce e tiene con sé come fosse al tempo stesso un padre e un figlio da accudire e da proteggere. Il passo successivo per dare un senso compiuto a questo straziante percorso potrebbe essere, a mio avviso, un finale che porti l’ottenebramento di quell’uomo di chiesa alle sue estreme conseguenze: come ne Le due zittelle, il racconto di Tommaso Landolfi da cui Emma Dante aveva tratto il suo spettacolo La scimia, in cui i gesti della messa mimati dall’ignaro animale diventano spunto di una tormentata riflessione sulla grazia e sul libero arbitrio, l’inconsapevolezza di chi è detentore del culto potrebbe sfociare nell’eresia o nell’ascesi, nel sacrilegio o in una provocatoria espressione del divino, che sono in fondo i due volti di uno stesso mistero, intimamente e scandalosamente legati.
l’Unità - Maria Grazia Gregori - 13/06/2016
[…] Fa pensare Il Vangelo secondo Antonio scritto, messo in scena e interpretato da Dario De Luca dopo una documentazione sul campo dove si racconta di un parroco che, malato di Alzheimer, vive in una realtà parallela per gli altri impenetrabile. […]
Repubblica.it - Valentina De Simon - 25/11/2016
Don Antonio è un parroco qualunque di una sbiadita provincia calabrese. Le sue croci quotidiane sono i migranti scampati all’ennesimo naufragio da sistemare, le intemperanze abituali della sua comunità da gestire, le mediazioni telefoniche con un vescovo che è sempre troppo distante. La sua devozione è un atto di fede rivolto al prossimo, a quei poveri cristi che ogni giorno si trova ad accarezzare con il suo sguardo fervido e benevolo. Al suo fianco, a condividere gioie e fatiche della sua missione, la sorella Ricordina, per tutti Dina, perpetua premurosa e piena di rispetto, e il giovane seminarista Fiore, braccio destro anche durante le funzioni. A Don Antonio piacciono le canzoni di Gianni Bella e, in fondo, anche questa sua vita agitata, in continua emergenza, fatta di notti insonni e giornate piene. Non dà di certo peso a qualche dimenticanza di troppo, né d’altronde ha tempo per soffermarvisi, visto che c’è sempre qualcun altro, lì nei paraggi, ad aver bisogno. Ma quando la situazione peggiora e quelle piccole disattenzioni si rivelano segnali conclamati del morbo di Alzheimer, per Don Antonio e la sua fedele Dina inizia un lungo, inarrestabile calvario. Il Vangelo secondo Antonio, scritto, diretto ed interpretato da Dario De Luca insieme a Matilde Piana, una commuovente e volitiva Ricordina, e a Davide Fasano, nei panni dell’assistente sodale al suo parroco ma anche pronto a prenderne il posto, quando ormai la demenza avanza, è un pugno allo stomaco che non ti aspetti, che ti sorprende alle spalle e ti lascia inerme. Perché, pur maneggiando una materia drammaturgica insidiosa, quella della malattia, sa sublimarla in una parabola più complessa dove trovano posto il dolore, la dottrina religiosa, i giochi di potere e le gerarchie, in primis quelle famigliari. Perché scava nella complessità dell’animo umano mettendone in discussione logiche e reazioni. Perché sa mostrare la tenerezza della fragilità senza cadere nello sgambetto del pietismo o dell’eccessivo sentimentalismo. Sulla scena inquadrata da una cornice di ferro che divide il proscenio, abitato da un pouf e da un tavolino, dal fondale, adibito ad altare sul quale svetta un imponente crocifisso che sovrasta tutti, i tre attori si muovono con disinvoltura e precisione, assecondando le profondità del testo senza mai forzarle. Led luminosi opportunamente azionati rivestono l’intelaiatura metallica disegnando antri e geometrie inclusive al suo interno mentre l’impianto luci, efficacemente modulato, contribuisce a mantener viva una dinamica di campo e fuori campo con entrambi i piani del palcoscenico. Dario De Luca sorprende per il suo Don Antonio prima testardo e carismatico poi sempre più labile, spaventato, disorientato da un male che annienta certezze e ricordi per lasciare posto ad uno sconfinato vuoto. Quando, oltre alla sorella che lo cura con amore, è al crocifisso che rivolge le sue più ossessive attenzioni, tirandolo giù dall’altare e stringendolo fra le braccia per coprirlo e proteggerlo, Don Antonio diventa lui stesso, con la sua sofferenza di uomo qualunque, corpo e sangue offerto in sacrificio per tutti noi.
www.teatroecritica.net - Sergio Lo Gatto - 19/11/2016
Nel sacramento del battesimo, dice la catechesi, risiede l’atto fondativo di tutte le Chiese cristiane. Lì sta l’atto di fede più cieco, l’abbandono meno consapevole, lì si manifesta il passaggio più vicino ai riti di iniziazione di ogni altro culto pagano. Ci viene chiesto – quasi sempre in qualità di neonati – di riporre l’intera nostra vita (e le opere che ne conseguono) nelle mani di Dio e del Cristo, salvo poi comprendere meglio, da grandi, il magico valore del libero arbitrio. Se chiedessimo a una platea di spettatori quanti di loro sono stati battezzati, certamente le mani alzate sarebbero la maggioranza. Nella Sala Orfeo del Teatro dell’Orologio di Roma è arrivata una nuova versione di Il vangelo secondo Antonio, denudata di quasi ogni orpello scenografico che caratterizzava la prima – che aveva visto il debutto a Primavera dei Teatri 2016 – per uscirne rinata, trasfigurata, finalmente in grado di esprimere una potenza performativa, testuale ed etica. Padre Antonio (Dario De Luca), parroco della provincia calabrese, è un vero e proprio esempio di buon pastore: iperattivo e premuroso, con il polso fermo di chi sa di voler e dover comprendere i problemi di una comunità, si adopera per accogliere i migranti scampati all’ennesimo naufragio, interloquisce con il vescovo, dà ordini al giovane Fiore (Davide Fasano) e alla perpetua, la sorella Ricordina (Matilde Piana). Finché, cominciando da piccole dimenticanze e lievi incoerenze, non scoprirà di aver contratto il morbo di Alzheimer, che lo condurrà a una degenerazione rapida e dolorosa, interamente mostrata. Solo un tavolino e un pouf campeggiano su una scena scarna, in cui un’intelaiatura di ferro battuto disegna gli spazi accendendo i vari segmenti con una fila di led. Sull’estremo fondale veglia un grande crocifisso, occhio onnipresente e onnisciente che a metà dello spettacolo verrà a sua volta denudato del Cristo, tirato giù da Padre Antonio come ennesima – e forse unica – anima da salvare, ora che la propria sta perdendo la ragione. I due spettatori di questa dissoluzione della personalità divengono allora due figure-simbolo: da un lato c’è la famiglia, quella sorella che, all’inizio del suo sacerdozio, faceva fatica a dare del tu al fratello per paura di mancare di rispetto alla sua posizione; dall’altro c’è il credente, il giovane seminarista che fa di tutto per aiutare ma che in fondo – e qui sta la sottigliezza del ragionamento di De Luca – gioisce per l’opportunità ricevuta dal vescovo di ereditare la parrocchia del proprio maestro. La costante presenza della croce (sulla scena e nei discorsi dei personaggi) ricorda a tutti il concetto del sacrificio e insieme quello della Fede, il pegno pagato da ogni anima devota al servizio di un compito in fondo mai svolto fino in fondo. Perché, parafrasando Tolstoj, in questa vita lavoriamo per la prossima, ma di questa vita non ricorderemo le giuste azioni, solo le scelte errate che ci avranno portato al giudizio del Creatore. Maneggiando con abilità la retorica cattolica e, in maniera affilata, facendone emergere le criticità, il testo di De Luca riesce nell’intento di distribuire il piano etico su quello delle relazioni, rivolgendo la domanda sul libero arbitrio – che è il vero mistero della Fede – sulla crudele materialità delle azioni quotidiane. Sono molti, in sala, gli occhi lucidi. Qualcuno non resiste, si allontana dalla sala per piangere qualche lacrima. Perché tutti e tre gli attori, impegnati nel contrasto tra un testo piuttosto classico, un’interpretazione naturalista e però sullo sfondo di un ambiente scenico rarefatto, complottano per la messa a nudo della fragilità umana. Diverse sequenze – che a raccontarle qui suonerebbero quasi didascaliche – trovano potenza nella commistione tra dimensione umana (e quindi spirituale) introdotta dalle relazioni tra i personaggi e dimensione materiale (Heidegger la chiamerebbe l’esser-cosa, la cosità) messa a fuoco dai particolari della vita quotidiana rimescolati dalla decadenza cerebrale.
Pur se frutto di un’attenta ricerca anche sulle dinamiche del morbo di Alzheimer, l’operazione messa a punto da Dario De Luca va oltre e diventa così, grazie a una grande eleganza nella messinscena e nella direzione degli attori, una parabola complessa sulla religione, sul sacrificio, sulla malattia e sul potere. Facendo un azzardo di condensazione, potremmo dire che è innanzitutto una parabola sul corpo. La decadenza cerebrale mette in disordine ogni tipo di certezza e riorganizza, malgrado tutto, i rapporti di potere, inverte le gerarchie, alla croce viene sottratta la grazia della ricompensa spirituale. E infatti proprio la croce resta lì appesa, liberando dell’icona solo la parte più umana, che ha ancora – dopo più di duemila anni di evoluzione – bisogno di essere scaldata, coperta, protetta dalle sue stesse terribili nudità.
www.rumorscena.com – Roberto Rinaldi – 20/02/2017
[…] La scena si presenta scarna, pochi oggetti essenziali, una cornice metallica illuminata con i led, semplicissima quanto efficace per creare una sorta di visione intimistica, e un crocefisso al centro. L’atmosfera è rarefatta e circondata dal nero del palcoscenico adatto a creare una sorta di visione intimistica della storia: un prete si ammala di una patologia invalidante com’è l’Alzheimer, la sua vita subisce una regressione tale da impedirli di proseguire nella sua missione. Il sacerdozio, unitamente alla sua persona, si fondono per dare vita ad un’esperienza di sofferenza, come se la malattia avesse minato le sue convinzioni terrene nel tentativo di immedesimarsi (in qualche modo) nella figura cristologica. Si assiste ad un dialogo tra un uomo che necessita di cure e una donna (la sorella) e perpetua del sacerdote, votata ad ogni sacrificio pur di alleviare le pene del fratello. È il fulcro iniziale su cui ruota la vicenda e dove la bravura del protagonista emerge a pieno, il suo personaggio nella fase della malattia conclamata, viene reso con abile interpretazione commovente per certi versi, affiancato da una bravissima e misurata Matilde Piana, così credibile nella parte di una donna che si sacrifica nel portare tutto il peso dell’umana pietà e compassione, per il fratello privato della sua dignità. Da qui in poi la resa scenica convince sempre di più. Si assiste ad un crescendo continuo dettato dai dialoghi e dalle azioni che sono state riviste, eliminando certi eccessi a scapito di una introspezione precisa – di cosa comporta realmente ammalarsi – , senza enfatizzare ma descrivere realisticamente quanto sia difficile affrontare e gestire la gravità di un malato in queste condizioni. Cosa comporta assistere un parente senza cedere alla disperazione. Non solo: anche la fede viene colpita nella sua essenza; il parroco così impegnato nelle sua attività pastorali e sociali, si annichilisce sempre di più e cerca conforto con il corpo (metaforico) di Cristo, sceso dalla croce e abbracciato come unico sollievo psicologico e spirituale, senza possedere la capacità razionale di comprendere i propri agiti. Cosa comporta addentrarsi nella condizione più profonda dell’animo umano? Un rebus misterioso e insondabile. Non ci sono risposte certe ma si prova una sorta di spaesamento, di smarrimento, volutamente reso dalla scrittura drammaturgica. Il giovane prete, assistente di Don Antonio (il giovane attore Davide Fasano), prenderà il suo posto e sarà promosso, come a significare che la vita continua e la sua missione proseguirà nelle mani di un altro. Purificato da una scenografia che toglieva spazio ma soprattutto la dovuta concentrazione nel capire le dinamiche che sono alla base del problema sanitario e specialmente sociale assistenziale, “Il Vangelo secondo Don Antonio”, è una testimonianza utile che permette (anche) al teatro, di sensibilizzare l’opinione pubblica, e farsi portavoce di quanto sia necessario conoscere e saper affrontare con tutti gli strumenti più idonei per affrontare un’emergenza sempre più grave.
Krapp’s Last Post - Mario Bianchi - 22/12/2016
Avevamo lasciato Dario De Luca, con Saverio La Ruina una delle due anime della compagnia calabrese Scena Verticale, impegnato in un interessante percorso di teatro canzone.
Lo abbiamo ritrovato al Teatro Ringhiera di Milano in “Il Vangelo secondo Antonio” nei panni di un povero prete, don Antonio, parroco di una chiesa sperduta della Calabria. Don Antonio è un prete caparbio e pieno di speranze verso un futuro difficile ma migliore. Sembra facile il compito pastorale di don Antonio, ma non è così; la giornata è puntellata di piccole e grandi incombenze: bisogna “dire” messa, preparare le prediche, celebrare matrimoni e funerali, evitare che ogni festa sacra diventi una baracconata, ma soprattutto sistemare gli ennesimi migranti scampati alla forza del mare. E c’è pure da avere a che fare con un vescovo che recalcitra ad ogni sua ragionevole proposta di cambiamento. Per fortuna, al suo fianco, da sempre vi è la fedele sorella Dina, perpetua solerte e rispettosa, e poco più in là il giovane seminarista Fiore, che gli dà una mano in occasione delle funzioni. Durante la Messa, indicando il crocefisso che lo sovrasta, don Antonio continua a ripetere che sì, “bisogna che ognuno, proprio ognuno, debba portare la sua croce avendo fede in Cristo”. E la sua croce improvvisamente arriva, prima pian piano, poi in maniera sempre più progressiva: l’Alzheimer si impossessa infatti del corpo di don Antonio. Solo Dina gli sta, ancora e nonostante tutto, accanto, vivendo questo calvario, e osservando da vicino il decadimento fisico e mentale del fratello: “La malattia colpisce più me di lui, lui nemmeno se ne accorge, sono io che ne rimango svuotata, vedendolo morire giorno per giorno” va ripetendo. Antonio ora non riconosce più nulla, è solo al crocifisso che rivolge tutte le sue attenzioni, deponendolo dall’altare per cercare di consolare quel povero giovane così solo e sofferente, messo in croce senza nessuna colpa. Lo fa forse perché quel giovane assomiglia così tanto a lui, e come quel giovane in croce soffre di una morte lenta e “vigliacca”. La scena de “Il Vangelo secondo Antonio” è volutamente povera, con semplici oggetti che la punteggiano, un pouf e un tavolino, mentre in fondo si erge una specie di altare, sul quale svetta un imponente crocifisso. Una cornice di ferro ricoperta di led luminosi disegna i vari ambienti in cui si svolgono le scene, resa partecipe dalle musiche, tutte inedite, composte da Gianfranco De Franco, ma anche dalle canzoni significative di Gianni Bella (“Sei quello che sei, ma non ci sei”), con frequenti riferimenti alle Pietà rinascimentali. Lo spettacolo, che prende spunto da una vicenda realmente accaduta, è scritto, diretto ed interpretato con efficace adesione da Dario De Luca, insieme a Matilde Piana, una commossa e commovente sorella complice nel dolore, e a Davide Fasano. Risulta, alla fine, più che uno studio reale ed emotivo sull’Alzheimer, che comunque viene osservato capziosamente in tutto il suo percorso degenerativo, una bella e composta riflessione sul tema del dolore, coniugato con quello della fede, spesso nella vita accomunati, capaci di scombussolare le logiche e le reazioni degli esseri umani. Ed è in questo senso che lo spettacolo si fa amare, pur nei limiti di un teatro di stampo tradizionale, che tutto dice e suggerisce, ma che al contempo ci fa scoprire direzioni inaspettate di un autore come De Luca, che sta cercando con caparbietà una sua poetica attraverso uno stile ancora in divenire.
www.famigliacristiana.it - Albarosa Camaldo - 12/12/2016
In un paese della Calabria, Don Antonio si dedica con passione ai suoi parrocchiani, ai migranti, si occupa dei terreni confiscati alla mafia, con l’ aiuto della sorella Ricordina, detta Dina e del suo allievo, il seminarista Fiore. Ma un giorno, arriva un ospite inatteso, l’ Alzheimer, a sconvolgere la vita dei tre personaggi e della comunità parrocchiale. Il testo, Il Vangelo secondo Antonio, scritto da Dario De Luca, con la consulenza di un medico specialista, e messo in scena dallo stesso autore, con realismo, ma anche con delicatezza, evidenzia le caratteristiche del morbo, oggi ancora incurabile, e diviene un’ attenta, ma umanissima indagine su quello che accade in una “famiglia” quando irrompe una malattia degenerativa che mette a dura prova la vita anche di chi si occupa del malato. Quando poi chi si ammala ha un ruolo pubblico, come quello del sacerdote, tutto si complica: prima è necessario nascondere ai parrocchiani la verità, poi bisogna trovare un sostituto. Toccante la costruzione del personaggio della sorella di don Antonio, interpretata da Matilde Piana, che prima, pur sapendo come progredirà la malattia, si spazientisce, mostra insofferenza verso colui che non riconosce più come suo fratello, come quando, incredula, lo osserva, mentre non riesce a sbottonarsi la tonaca e gli urla “ma lo sanno fare anche i bambini di quattro anni!”; mentre poi accetta con serenità la sua missione di stargli accanto, tenendo con sé i ricordi del passato, e si rifiuta di prendere una badante, ma si prende cura amorevolmente di lui, come faceva anche prima, cambiando solo i rituali: invece di aiutarlo nei preparativi della messa, gli prepara le medicine, lo incita a pronunciare le parole, con una tenerezza infinita, come se gli insegnasse di nuovo a parlare. Il giovane seminarista, Fiore, interpretato da Davide Fasano, nel frattempo, diventa sacerdote e prende il posto di don Antonio e gli resta vicino per aiutarlo e confortare la sorella. Nel corso dello spettacolo abilmente gli attori cambiano il loro atteggiamento, senza nascondere la loro fragilità: Dina, prima orgogliosa del fratello sacerdote, ora si sente spesso triste, stanca, ma poi riprende coraggio, mentre Antonio, dapprima forte e determinato, cambia registro e si mostra spaesato, e, nei rari momenti di lucidità, si preoccupa per il pensiero di condannare la sorella ad anni di infelicità nell’ assistere al suo progressivo peggioramento e definisce questa malattia l’ unica che fa soffrire chi assiste il malato più che il malato stesso, poiché essa “non tocca il guscio (il corpo), ma distrugge solo l’ interno dell’ uomo (la mente)”. Tutti e tre gli attori alternano rapidamente differenti stati d’ animo: dapprima vivono la normalità, poi mostrano serenità, quando sfruttano i momenti di lucidità, lasciandosi andare anche agli scherzi o a battute, come mentre ascoltano le canzoni di Gianni Bella, il cantante preferito di Antonio, per poi ripiombare nel dramma. Cornici di ferro, che frammentano la scena a simboleggiare i ricordi confusi, sono animate da luci a led che irrompono per sottolineare i momenti di perdita di cognizione della realtà, come quando Antonio, di notte, si agita molto di più e cerca il bagno fino a che, non trovandolo, perché non riconosce più la sua casa, non si trattiene più e poi piange. Oppure quando chiama disperato qualcuno che lo riporti nella sua casa, nonostante ci sia già, e vuole uscire portando con sé una statuetta di un santo che gli è ancora familiare. In alcuni momenti drammatici gli attori si bloccano, come in un fermo immagine, per richiamare alla mente degli spettatori la ieraticità di alcune pale d’ altare e sottolineare l’ impossibilità di cambiare le situazioni drammatiche che stanno vivendo. E il rapporto con la fede di don Antonio come cambia? Dapprima don Antonio ricorda le frasi che ha pronunciato tante volte durante le funzioni, ma che per lui, con il degenerare della malattia, si svuotano del significato: si accinge a distribuire la Comunione, ma poi si strania e divora le ostie, inzuppandole nel vino, come se fossero biscotti; si reca a confessare una parrocchiana, ma non ascolta quello che lei gli dice e ripete solo le formule sul perdono. Ma quello che rimane intatto, nonostante la malattia, è il suo amore per Gesù in croce che lo tocca nel profondo. Dapprima, vaneggiano, telefona al vescovo per parlargli di un’ ingiustizia terribile che ha subito un uomo condannato da Ponzio Pilato, poi vuole aiutare la statua del suo Gesù crocifisso, che è sullo sfondo della scenografia, e la stacca dalla Croce fra lo sgomento della sorella e di Fiore, la porta in spalla, avendo compassione come il cireneo. Poi la accudisce, chiamandola padre, anche quando è ridotto a una larva e non riconosce più nessuno. Alla fine, mentre pronuncia solo la parola Rabbi, guardando la statua, è impossibile trattenere la commozione: Antonio depone amorevolmente sul corpo e sul volto del suo Gesù morto il lenzuolo di lino che Fiore gli ha portato, come gli aveva promesso, quando stava meglio. I tre attori rimangono in silenzio, attorno al Cristo deposto sulle ginocchia dell’ ex sacerdote, a suggerire l’ iconografia di una pietà, ma dei nostri giorni.
Ateatro.it - Leonardo Mello - 17/07/2016
[…] Tra le proposte più riuscite della rassegna si collocano altri due spettacoli, Il Vangelo secondo Antonio di Dario De Luca e Geppetto e Geppetto di Tindaro Granata. Il primo, anche diretto e interpretato dall’autore, racconta la storia di un prete di frontiera dai tratti “francescani”, che si fa in quattro per dare accoglienza ai rifugiati che arrivano sulla sua isola con i soliti barconi, e nel farlo dimostra un piglio e un carattere che lo mettono talvolta in contrasto con le gerarchie ecclesiastiche cui deve rispondere (è vicario generale del vescovo) e con le autorità politiche locali. Il problema è che, nel corso del tempo, si manifestano in lui i sintomi di un Alzheimer precoce, che lo conduce progressivamente alla demenza. Tratta da una storia vera, la pièce ripercorre gli stadi di una tra le malattie più vigliaccamente feroci, che costringe chi ne è affetto all’inesorabile perdita della dignità. Lo spettacolo ha un approccio fortemente “naturalista” (“Perché no?”, dice lo stesso De Luca), ma possiede tutti gli elementi per appassionare e anche trasmettere – tra le righe – informazioni su questo funesto e inguaribile morbo. Forse, nella fase finale, pecca un po’ di didascalismo (probabilmente indotto dall’approfondito studio della patologia da cui tutto prende le mosse), e, a debutto avvenuto, sarebbe meglio accorciare queste “lezioni informative” innescate nel testo. Ma resta il fatto che l’allestimento ha una potente forza emotiva, convince anche nella parti più “realistiche” e offre uno spaccato autentico della sofferenza. Buone le prestazioni dei tre attori, a partire dal protagonista De Luca ma senza dimenticare la zelante e amorevole sorella del sacerdote, Matilde Piana, e il pretino (destinato a soppiantare don Antonio nella parrocchia) interpretato dal bravo Davide Fasano. Suggestivo il finale cristologico e visionario. […]
Stratagemmi.it - Valentina Provera - 04/06/2016
“Sei quello che sei, ma non ci sei”: le note di Gianni Bella accompagnano la discesa agli inferi di don Antonio, parroco di una piccola comunità che, ammalatosi di Alzheimer, perde progressivamente la capacità di compiere anche i gesti più semplici e quotidiani. La malattia “ha il nome di un cacciabombardieri tedesco, che lascia crateri, spara bombe” e infatti la quotidianità di Don Antonio viene minata, salta quasi per aria. Al posto degli impegni presi per soccorrere profughi o gestire terreni sottratti alla mafia, rimangono solo farneticamenti notturni, funzioni celebrate come un disco rotto e parole che smarriscono il loro senso. Don Antonio precipita in una perdita di sé tra coscienza e incoscienza (“Qualche cellula del cervello mi ha lasciato, ma che devo fare, stare in lutto per ciascuna?” dice in una telefonata al vescovo), tra paura e abbandono, tra nervosismi e disperata ricerca di affetto. Nella spirale di oblio in cui cade, Antonio (Dario De Luca) allontana da sé anche le due figure che lo hanno sempre assistito: Fiore (Davide Fasano), giovane diacono che, pur non tradendo mai l’affetto sincero per il suo maestro, farà della sua malattia la propria occasione di carriera e la sorella Ricordina (Matilde Piana), che porta inscritto nel proprio nome – antifrastico alla malattia del fratello – tutto il dolore che prova per lui. Il dramma forse ancora più profondo ed amaro che Dario De Luca porta in scena con grande profondità psicologica, è quello di chi assiste il malato: “Il dolore non lo prova il malato, ma chi lo assiste” dice Dina affranta. Di fronte alla metamorfosi del fratello, alla sua progressiva regressione infantile, al suo smarrimento, ella è smarrita a sua volta. Ora incredula, ora stizzita, ora spaventata, ora ironica, quasi sarcastica, Dina è ‘perpetua’ nel coraggio di stare accanto al fratello, non senza cedimenti e fragilità. Attraverso questo personaggio, De Luca conduce lo spettatore tra le pieghe più recondite dell’animo umano, laddove si celano la meschinità e la piccolezza che solo un dolore straziante come quello di una malattia degenerativa porta alla luce. La sua indagine non si ferma qui, ma prosegue in un confronto con il sacro che non è né moralistico né retorico: De Luca, ideatore ed interprete di Don Antonio, attraverso la smemoratezza del protagonista, spoglia il rapporto con il divino di ogni sovrastruttura e ne fa un afflato spontaneo, quasi innato: così l’icona di Cristo ‘scesa’ dal crocefisso è riconosciuta dal parroco malato come qualcosa che lo “riguarda personalmente”. È questo svelamento crudo delle debolezze e delle grandezze della psiche forse l’atto più coraggioso di uno spettacolo che non osa invece troppo dal punto di vista formale. La scenografia si àncora a una dimensione ipernaturalistica: la forza dell’immagine cristologica è tale da rendere superflua la pesante struttura che diviene ora altare, ora tabernacolo, ora confessionale, e infine sfondo di una sacra rappresentazione. L’indagine sul terreno metafisico del sacro potrebbe muoversi più leggera libera dai vincoli e della ridondanza di dettagli concreti.
Teatrionline.com - Paolo Verlengia - 20/04/2018
C’è un prima ed un dopo ne “Il Vangelo secondo Antonio”, scritto ed interpretato da Dario De Luca, con Matilde Piana e Davide Fasano. C’è uno iato fondamentale in termini drammaturgici, che sulla scena provoca un cambio di passo netto nello spettacolo. Fin lì tutti i motivi dell’azione provocano il sorriso, come reazione dominante. Da quel punto in poi invece -benché i segni fondativi rimangano gli stessi- lo spettacolo emoziona e commuove.
Ecco perché Il Vangelo secondo Antonio è un lavoro che sorprende lo spettatore anche se ne conosce già la trama, per averla letta o sentita. La storia narrata è quella di un parroco della provincia meridionale che viene colpito da morbo di Alzheimer. Tanto lo vediamo attivo, dinamico, lucido e combattivo prima, tanto lo vedremo fragile poi, gradualmente. Per questo motivo i due tempi dell’azione sono determinanti, e per lo stesso motivo lo spettacolo necessita della presenza degli altri due personaggi, Dina la sorella e perpetua di Don Antonio e Fiore il giovane diacono, drammaturgicamente imprescindibili al pari del protagonista. Allo stesso tempo il cosa accade -benché determinante- trova il suo reale compimento artistico nel come esso si manifesti in scena. L’andamento per quadri intervallati dal buio ricorda per certi versi quello del teatro epico, in cui convivono una recitazione realistica ed una scenografia scarna ed allusiva, ma non simbolica: gli elementi presenti sono finalizzati all’azione ed alla vicenda rappresentata (il telefono che filtra gli interventi del vescovo, il crocifisso sullo sfondo, un sacco nero sul lato destro che in virtù della sua neutralità si rivela elemento polifunzionale, in grado di virare di senso e di uso nei due diversi tempi dell’azione). I diversi ambienti necessari per ragioni narrative (altare, sagrestia, confessionale, camera da letto…) sono resi brillantemente tramite una struttura che spezza nettamente con il resto degli elementi scenografici, a sottolineare una volta di più quel mutuo sorreggersi dei due tempi dell’azione. Il cuore della vicenda sta nel cosa rimanga o nel come evolva il rapporto con la fede in un religioso colpito da un male degenerativo e progressivo. Con assoluta rarità in ambito artistico -specie quello italiano- il tema ed i simboli della religione cattolica non vengono utilizzati come elemento da dissacrare o da mostrare nella loro contraddizione. Non avviene alcun utilizzo politico, comico e nemmeno ironico del sacro, che anzi guadagna sostanza, materica e significante. La mancata dissacrazione lascia anzi il passo ad un processo di sacralizzazione disseminata in ogni più piccolo gesto ed elemento scenico man mano che lo spettacolo incede. Il conflitto drammaturgico che qui si inquadra attiene alle meccaniche più pure del fare teatro, quelle che hanno fatto del teatro uno strumento prediletto per l’analisi del mondo interiore. Così -secondo la migliore tradizione- lo spettacolo si presenta nella forma di un crescendo, in cui i motivi artistici lievitano assieme alle performance degli attori. Matilde Piana raggiunge per intensità la prova di Dario De Luca, in virtù di una struttura ben precisa del dramma, che prevede un travaso di protagonismo dal personaggio di Don Antonio a quello della sorella Dina. I due vengono a formare una diade, delicatissima e disperata, dove la speranza brilla in fondo agli occhi lucidi di una donna che sostiene tra le braccia il sospiro ritmico di un uomo.
Il Quotidiano del Sud - Ilaria Nocito - 09/06/2016
Come un Cristo sulla croce. Come pane consumato. Perché l’Alzheimer “ha il nome di un cacciabombardiere tedesco che spara missili e lascia crateri enormi”. Perché “è una malattia bastarda, che ti svuota lasciando il guscio intatto e senza crepe”. Ti cancella il pensiero e la volontà. Ma non l’amore che resiste nelle pieghe più nascoste dell’animo umano. È questa la storia di Don Antonio Cantalamessa e di tutto il suo Vangelo. Che a volte il teatro serve anche a questo, a raccontare una vita e il suo dolore. Come in un viaggio catartico il nuovo spettacolo scritto e diretto da Dario De Luca di Scena Verticale. Così “Il Vangelo secondo Antonio” ti prende tutto d’un fiato e ti inchioda alla poltrona per poco più di un’ora. Ad una prima nazionale di Primavera dei Teatri a Castrovillari andata sold out. Un testo poetico ed evocativo, di raffinata sensibilità e originalità (non soltanto per la scelta del tema). Che arriva dritto al cuore dello spettatore con un ritmo a metà tra amarezza e ironia. E di cui lo stesso De Luca è abilmente autore, attore e regista. La sua voce apre la scena e presenta il protagonista, Don Antonio, un parroco di una piccola comunità calabrese, brillante vicario generale del vescovo, attivo nell’accoglienza dei profughi e nella gestione dei terreni confiscati alla mafia per cui “il peccato è l’omissione, voltare la testa dall’altra parte” e “le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano”. Accanto a lui la sorella perpetua Ricordina (già nel nome in antitesi con la malattia l’umorismo tragicomico dell’opera), dapprima dura con lui, poi amorevole, e il suo fedele e giovane diacono, Fiore, dal carattere candido e delicato. Ma quando il prete si ammala di Alzheimer tutto cambia. La loro vita non sarà mai più la stessa. Il percorso degenerativo della malattia rivela la rabbia, la sofferenza e le difficoltà che ci sono dietro il malato e la sua famiglia. E proprio quando Don Antonio non ricorderà neanche più la stessa malattia si aggrapperà alla sua interiorità e scoprirà un rapporto più autentico e spontaneo con il Cristo, la sua “coperta di linus”. Una vera e propria discesa verso l’inferno la malattia raccontata nello spettacolo con coraggio e maestria. Forti le scene dei santi in fila che se ne vogliono andare e la pipì che scappa, lo sforzo di ripetere le parole con la “effe”. Straordinaria e intensa l’interpretazione di De Luca nei panni del don di cui rende più sfumature. Impossibile dimenticarlo seduto sull’altare col pannolone mentre si agita come un re in preda alla follia, rimpicciolito nel corpo e col Cristo in braccio mentre gli infila i calzini neri sulle mani per coprirne i chiodi (che la nudità umilia come la demenza) o con il Cristo a terra e lui a fianco mentre lo accarezza teneramente come un figlio sulle parole di “Sei”, la canzone di Gianni Bella. Sul palco armonicamente insieme a lui, il giovane talento di Davide Fasano, d’impeccabile naturalezza nella parte di Fiore e la forza scenica e trainante di Matilde Piana nel ruolo di Dina. D’impatto visivo la scenografia con un imponente trittico grigio (in contrasto con i colori dei costumi), a simboleggiare la trinità. Dominato dall’alto da un grande crocifisso sospeso divide l’ambiente scenico in verticale, tre piani (o livelli), quello terreno (con il palco disegnato da un riquadro di luci a led), mediano e celeste. Le musiche, tutte inedite, composte da Gianfranco De Franco, fanno da culla all’intera drammaturgia, arricchendola di suggestioni. E mentre il pubblico in piedi e ancora commosso non smette più di applaudire emoziona l’immagine finale di Antonio che copre col suo lenzuolo bianco (come un sudario) la statua nuda del Cristo tenuta con devozione sulle gambe. Come la Pietà.
Ilpickwick.it - Michele Di Donato - 07/07/2016
[…] Il penultimo giorno di Festival si apre con lo spettacolo proposto dai padroni di casa di Scena Verticale, Il Vangelo secondo Antonio, scritto diretto e interpretato da Dario De Luca. Messinscena che nella sua semplicità compositiva trova la chiave di un’efficacia espressiva con cui raccontare, delicatamente e in maniera realistica, una normale storia di malattia progressiva, di quelle malattie che ti logorano a poco a poco, togliendoti chi è caro facendoti dapprima uscire dai suoi pensieri e dai suoi ricordi e poi progressivamente lasciandoti il fardello di un accadimento straziante. Dario De Luca è Antonio, parroco dalla sensibilità non formale, una sorella a far da perpetua, un giovane prete ad accoglierne gli ammaestramenti. Il racconto del procedere degenerativo di una malattia crudele è scandito da una leggerezza che non inficia la serietà del tema trattato, ma anzi lo coniuga nel modo migliore, mostrando peraltro come i residui coscienziali che resistono temporaneamente all’oblio non scalfiscano l’intima aderenza morale dell’uomo al proprio ministero. Ben recitato e ben costruito – sebbene privo di elementi teatralmente rilevanti – Il Vangelo secondo Antonio sembra dimostrare che si può costruire drammaturgie dignitose senza necessariamente affaccendarsi alla ricerca di arzigogoli concettosi. […]
Corrierespettacolo.it - Claudio Facchinelli - 01/07/2016
[…] Dario De Luca, autore, regista ed interprete, dimostra di saper declinare con efficacia la sua capacità attorale anche su un terreno drammatico per lui meno consueto, coadiuvato da una buona squadra di attori, alcuni al loro debutto.[…]
www.asteriscoduepuntozero.it - Antonello Fazio - 03/11/2016
… Buio. Antonio è solo. Si aggira spaesato nella sua casa. È impaurito, forse raggiunge scatti di rabbia. Ha l’impressione che le stanze non siano più al loro posto, qualcuno ha spostato il bagno. È perduto nella sua stessa casa. Dopo aver vagato un tempo interminabile è costretto a urinare dove capita. Ma la cerniera è un aggeggio difficile da gestire. Il bisogno è sempre più impellente. Si lascia andare, urinandosi addosso, lì dov’è. Si crea una pozza ai suoi piedi. Inizia a piangere.
Buio…L’Alzheimer in una didascalia. Il dramma di un uomo (e di chi gli resta vicino) raccontato per parole essenziali, scarnificate dal lento addio alla vita. Le parole di una delle tante note di regia scritte da Dario De Luca per il suo “Il Vangelo secondo Antonio”, lavoro presentato dal dioscuro di Scena Verticale nel giugno scorso a Castrovillari, in prima nazionale alla XVII edizione di Primavera dei Teatri. “Il Vangelo” riparte in questi giorni, dal Festival Città delle 100 scale di Potenza, per un lungo giro di repliche nei teatri di tutt’Italia. Forse uno dei passaggi più diretti ed efficaci – addirittura esemplare nel suo essere destinato a fluire nella costruzione di una drammaturgia di grande densità e al contempo di estrema delicatezza – del preciso racconto del morbo di Alzheimer, una delle malattie degenerative più inesorabili, crudeli e socialmente “pesanti” che si conoscano.
Solo una didascalia, un’indicazione, una traccia, ma cruciale nel mare di un testo che sa coniugare il rigore del reale con la sublimazione dell’arte. Essenza del teatro, che è finzione, mai bugia. Del resto, sulla qualità di una scrittura teatrale che a onor del suo autore si rivela sin nei minimi risvolti e negli orli di una terra di nessuno, incide non poco, secondo l’autorevole parere di Gerardo Guccini, professore associato al Dipartimento delle arti dell’università di Bologna, «la misteriosa concisione delle didascalie che, una volta tanto, intervengono nel dramma per come dicono le cose che accadono». “Il Vangelo secondo Antonio” è parola ma anche pittura. Giorno dopo giorno, scena dopo scena, si narra il progressivo declino e l’inesorabile straniamento di don Antonio Cantalamessa, prete colto e generoso che vive la sua missione pastorale a contatto di gomito con parrocchiani e migranti, convinto che «le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano». Don Antonio (Dario De Luca) perde pezzi di sé, letteralmente, una cellula nervosa in fila all’altra. Fino a ridursi ad una radicale nudità, non solo metaforica, ad essere spogliato degli amati abiti, defraudato di una coscienza e di un ruolo socialmente accettabili (e accettati). Solo, sebbene amorevolmente accudito da Dina, la sorella-perpetua (un’eccellente Matilde Piana), e da Fiore, l’affezionato diacono (un non meno bravo Davide Fasano). Unico, nell’accezione sia etimologica che antropologica del termine. Così, uno smarrimento dietro l’altro, nel corso di una sorta di drammatico cammino a ritroso, di regressione verso l’inesorabile epilogo, contro cui niente e nessuno possono alcunché, il protagonista viene sprofondato in uno spazio svuotato di logica e di tempo dove incontra, subendone l’estremo dileggio, i vari stadi del morbo: incontinenza, paura, vergogna, disinibizione, rabbia e esaltazione, stati allucinatori, paranoia. In lui, tuttavia, resiste una umanità ridotta all’osso della pura essenza. Gli rimane il sé bambino, ancestrale. Il senso del gioco. Il bisogno di calore e di rassicurazione. L’amore senza ragioni e senza utili. Una presenza condensata, di certo (ri-)conosciuta, su cui contare al punto di averne cura come un bambino ne avrebbe del suo migliore compagno di vita. Quel qualcosa di apparentemente irragionevole (ma come potrebbe essere altrimenti, nelle sue condizioni?) e di spiazzante, quell’oggetto totemico, quella presenza ineffabilmente muta che si materializza, si sostanzia in una croce e nell’uomo morente che vi è conficcato. Ad Antonio Cantalamessa, pastore di anime e uomo, fa compagnia una sofferenza smisurata. E, tra le nebbie dello smarrimento, una dignità nucleare che precede l’umanità sociale e, in qualche modo, le sopravvive. Dotati di un impianto scenico e drammaturgico ampiamente intessuto di immagini appartenenti all’iconografia cristiana (in un crescendo figurativo di grande bellezza e intensità che segna l’intera seconda parte della pièce), testo e messinscena, forse per pudore o per legittima incompetenza a procedere del mezzo-teatro, non pretendono di spiegare il mistero di quel legame che si rafforza via via che le energie di don Cantalamessa vengono meno. Non ci sono risposte, che se anche fossero plausibili saprebbero di didascalico, anche perché un malato di Alzheimer non può dire la sua, non può spiegarsi; semmai, spuntano suggestioni, domande, puntini sospensivi che esistono per indagare tra le pieghe delle emozioni. «Senza emozioni a cosa si partecipa?», chioserebbe il professor Guccini. Tuttavia, quel legame, al di là di qualsivoglia (e del tutto legittimo) punto di vista o delle più svariate concezioni del mondo e dell’umanità, sembra dichiarare lo stato di totale immedesimazione fra l’uomo e l’oggetto. Una sorta di scioglimento emozionale, empatico dell’uno nell’altro. D’altro canto, sin dai primissimi frammenti appare chiaro il riferimento della pièce al senso religioso – spirituale, se si vuole – che è in ogni essere umano. Ed è subito dichiarato come “Il Vangelo secondo Antonio” voglia raccontare l’Alzheimer ma anche essere una riflessione sulla fede; come provi a mettere in scena – si è scritto, talvolta fraintendendo o speculando, con un naturalismo «desueto e anticontemporaneo» – una tragedia che colpisce, in modo trasversale, una parte vieppiù crescente della popolazione mondiale, e che ha profondamente a che vedere con la natura umana stessa, nel senso di quell’intreccio inestricabile che si viene a creare tra malattia e persona. Di quell’abbraccio letale che mette a nudo tutta una serie di elementi insiti nella persona, di cose che, come sostiene De Luca, «ritornano sempre a galla, anche se in maniera bislacca, anche se usate fuori luogo e senza alcuna logica». Nel caso di don Antonio, fino ad una vera e propria ascesi determinata dal male. In un tale contesto, riprendendo a muoversi sul filo del ragionamento critico di Gerardo Guccini, «fare del malato un prete è una scelta stilistica, un’invenzione formale, un’opzione linguistica, che conduce a comporre un Caravaggio dei malati. E certo un caravaggesco “sole nero” è l’illuminazione giusta per la pièce.»
www.saltinaria.it - Pietro Dattola - 13/11/2016
“Sei quello che sei, ma non ci sei” – le parole e le note di Gianni Bella […] acquistano nuovi, dolorosi significati ne “Il Vangelo secondo Antonio”, l’ultimo lavoro di Scena Verticale scritto e diretto da Dario De Luca.
In provincia di Reggio Calabria, a Bivongi, un giorno accadde un fatto curioso. A messa il parroco, anziché offrire le ostie dell’Eucarestia, prese a mangiarle tutte, dinanzi ai fedeli esterrefatti. Lungi dall’essere un originale atto iconoclasta ispirato dal demonio, si trattava, in realtà, di un gesto dovuto a un altro tipo di bestia, il morbo di Alzheimer, che già da tempo si era impossessato del parroco. Traendo spunto da questo episodio, Dario De Luca di Scena Verticale – che peraltro da anni conduce a Castrovillari un laboratorio di teatro con allievi diversamente abili – ha scritto e diretto Il Vangelo secondo Antonio.
Don Antonio è il parroco di una piccola comunità, estremamente attivo verso i più bisognosi (l’ultima emergenza: l’ennesimo sbarco di immigrati da accogliere e sistemare dignitosamente nonostante le rimostranze “dei piani alti”) che viene colpito dal morbo. Innocue, prima, e poi inquietanti dimenticanze, fanno pensare che qualcosa non vada, finché la diagnosi non diventa certa. A badare a lui, già da una vita, è Dina (diminutivo di Ricordina), la sorella-perpetua. Per nulla spaventata dal lungo elenco di accorgimenti da prendere per evitare che col passare del tempo il fratello diventi un pericolo per sé e per gli altri, Dina sceglie cristianamente di caricarsi addosso questa croce. In questo consiste la più evidente linea di lettura dello spettacolo, che in modo chiaro (con brevi passaggi oserei dire divulgativi tra le pieghe del testo) mostra la discesa inesorabile del parroco verso uno stato di guscio quasi vuoto e, di riflesso e con grande efficacia, la sofferenza di chi gli sta più vicino nel vedere una mente cancellarsi a poco a poco e nell’ assistere a una lunga – e per questo tanto più penosa – morte.
Se Dario De Luca ci conquista via via che Don Antonio “sparisce”, Matilde Piana vive l’incredulità, la tenerezza, la frustrazione, la rassegnazione, la rabbiosa impotenza e l’affetto che attraversano il corpo, prima ancora delle menti, dei familiari più stretti. “Sei quello che sei, ma non ci sei”, canta Gianni Bella, mentre Dario De Luca scende, scena dopo scena, nell’abisso, disorientato da una casa che gli sembra continuamente mutare, dimenticando il significato delle parole, non riconoscendo più i volti, perdendo ogni autonomia.
Una cosa sola non lo abbandona: il legame col Cristo in croce, sempre presente e in un modo o nell’altro illuminato sulla scena. Non è più Cristo, ovviamente: prima diventa una persona da sottrarre alle sevizie di cui è vittima, poi una cosa che Don Antonio sente riguardarlo “personalmente” e per la quale manterrà, nei limiti imposti dalla malattia, il massimo affetto – lo stesso, e qui si avverte una fitta al cuore, di cui egli stesso, e tutti coloro che si trovano in condizioni simili, rimangono bisognosi, anche quando non sono più in grado di chiederlo.
nucleoartzine.com - Federica Terribile - 01/12/2016
In scena uno spettacolo sull’assenza. Dario De Luca, regista, autore, attore e fondatore a Castrovillari della compagnia Scena Verticale con Saverio La Ruina, porta sul palco del Teatro Orologio una piéce dedicata alle centinaia di migliaia di persone affette dal morbo di Alzheimer e alle loro famiglie, levando il suo canto in un Paese in cui il fardello di questa malattia, ancora incurabile, sembra essere un tabù. Come fossimo in un grande cervello, tutto si svolge tra le mura di una diocesi in cui una scenografia essenziale, costituita dallo scheletro di una parete rivestito di led, divide l’abitazione del parroco Don Antonio dalla cappella della chiesa, posta in fondo al palcoscenico e dalla quale si erge un grande Crocifisso illuminato fiocamente in modo da creare suggestivi chiaroscuri caravaggeschi. Sebbene stilizzati, i due ambienti ci trasportano subito nel quotidiano dei tre personaggi: Don Antonio, colto e amato parroco di Bivengi, sua sorella Ricordina, detta Dina, che vive con lui come perpetua e il giovane e onesto diacono Fiore. Sin dalle prime battute si viene coinvolti in un contesto familiare, con riferimenti ai problemi d’attualità, quali l’accoglienza degli immigrati approdati sulle coste italiane di cui Don Antonio, punto di riferimento della piccola comunità di Bivongi, vuole prendersi cura. Il sentimento di protezione e comprensione del protagonista nei confronti dei confratelli immigrati che, dopo il lungo viaggio in mare e le sofferenze vissute giungono su coste sconosciute privati della propria identità e costretti dalla contingenza a lasciarsi il passato e le proprie radici alle spalle per ricominciare da zero, sembra essere un primo indizio al tema affrontato nell’opera. Ancor prima dell’avvenimento che innescherà la trama, con un bell’effetto prospettico l’intero teatro si trasforma in chiesa, Don Antonio celebra la messa rivolgendosi al pubblico come se la chiesa si estendesse alla platea, dando inizio al rito teatrale. Da quel momento in poi inizia il dramma, l’azione, le prime dimenticanze di un parroco forse troppo stressato dalle mansioni della diocesi, o forse minato da un ladro di ricordi. Prendendo forma in uno spazio scenico ridotto all’essenziale, i dialoghi e la recitazione del trio sono tanto convincenti da tenere lo spettatore in pugno, ci si immerge subito nella storia e nei ritmi della loro quotidianitá con la potenza e le atmosfere proprie di quel filone del teatro di tradizione classica a tematica civile e dal sapore dolce-amaro, erede di Eduardo De Filippo.
La recitazione infatti è tanto naturalistica, priva di virtuosismi o artifici manifesti, da far affezionare il pubblico ai personaggi, senza però perdere di tecnica e di forza metaforica. Come sbirciando dalla serratura, in un succedersi di sequenze ben strutturate in cui nulla è superfluo o autoreferenziale, seguiamo la vita di Don Antonio il quale dà i primi segni di malessere, inizialmente sottovalutati e canzonati dalla sorella Dina. Via via le dimenticanze si fanno più gravi precipitando la vita dei due fratelli nella grottesca esistenza di oblio. Don Antonio viene infatti attaccato da una malattia incurabile che “ha il nome di un cacciabombardiere tedesco che spara e lascia crateri vuoti nel cervello…”: l’Alzheimer. Esattamente come la casa, Don Antonio diventa uno scheletro, un guscio vuoto. Le porte della casa lo ossessionano, gli pongono interrogativi che non è in grado di risolvere, le statue dei Santi si ribellano in comiche allucinazioni, ogni oggetto di cui va scordandosi l’utilizzo lo tormenta. Le pareti un tempo familiari si svuotano di significato, un labirinto di solitudine attraverso il quale solo la statua di Cristo conserva un’attrattiva per la labile mente di Antonio. Sente che è un qualcosa che lo riguarda personalmente, lo depone dalla croce e se lo porta con sè fisicamente e spiritualmente. Come un richiamo ancestrale la statua, di cui dimentica il nome, nella tipica postura della crocifissione, calzini alle braccia a mo’ di Rita Hayworth, culla l’uomo in un lento malinconico sulle note di Gianni Bella “Sei quello che sei, ma non ci sei”. Lo spettacolo racconta il progressivo decorso della malattia con efficacia espressiva dal punto di vista del malato e di chi lo assiste giocando sulle note della tragicomicità tipica di certe situazioni della vita tanto reali nella loro assurditá da essere al limite dell’immaginazione. La malattia vigliacca e ladra sottrae a poco a poco non solo i ricordi ma anche le capacità di ragionamento facendo regredire l’individuo allo stato infantile. Dario De Luca riesce a rendere con profondità ed efficacia interpretativa il veloce sviluppo della malattia assumendo di scena in scena atteggiamenti e posture che riflettono l’aggravarsi dei sintomi e il suo percorso di smarrimento. Di grande intensità l’interpretazione di Matilde Piana nel ruolo della sorella Dina, che decide di assumersi anche questa croce e votare ancor di più la sua vita alle cure del fratello che presto smetterà di riconoscerla, scambiandola per un momento, persino per una partner. Attraverso questo gioco di malintesi che alleggeriscono con tragico umorismo mai inverosimile, De Luca affronta diverse tematiche sotto punti di vista completamente nuovi, quelli di una mente dimenticata la quale, cominciando ogni giorno da una pagina bianca, è libera dalle sovrastrutture e dalla storia delle azioni. Mette a nudo l’essere umano privato della sua facoltà caratterizzante ponendo invece l’accento sulla sua meschinità e piccolezza che viene alla luce in una situazione limite come quella di una malattia degenerativa. Commovente la tenera rabbia della sorella che, presa da momenti di esasperazione e frustrante impotenza, quasi aggredisce il fratello,o meglio il suo involucro che non riesce nelle azioni più elementari,per poi rassegnarsi alla dolcezza della comprensione del gioco che incanta Antonio componendo un trittico simbolo nell’ultima immagine prima del sipario: la Pietà. Il vero dramma dunque non è quello di chi ha la malattia, inconsapevole, ma quello di chi resta presente a se stesso, nell’assistere un caro che c’è senza esserci. Uno spettacolo originale ed efficace nella sua semplicità che porta ad interrogarsi sulla ricerca di senso portando alla luce una malattia paradossalmente dimenticata dalla società che ignora quanto essa sia invece presente nella casistica clinica.
Sonda.life - Adelio Rigamonti - 01/12/2016
“Sei quello che sei, ma non ci sei”, refrain di una delle canzoni più note di Gianni Bella, accompagna il decorso del morbo di Alzheimer nella mente e nel corpo di don Antonio, un brillante sacerdote impegnato nel sociale soccorrendo profughi e gestendo beni sottratti alle mafie. Il morbo di Alzheimer, che “ha il nome di un cacciabombardiere tedesco che lascia crateri, spara bombe”, non lascia crateri solo nel malato che dimenticherà di dimenticare, ma anche e soprattutto in chi gli sta vicino accudendolo e soprattutto nei parenti più stretti che letteralmente muoiono ad ogni rincrudimento del male. Dario De Luca per stendere il suo testo, breve ma assai intenso, ha preso spunto da una relazione medica in cui si parla di un paziente di Bivongi, un comune della città metropolitana di Reggio Calabria, un sacerdote che cominciò a manifestare i segni della malattia sbagliando a pronunciare le omelie. Quel sacerdote leggeva le omelie pasquali a Natale e viceversa. Un altro segno del morbo di Alzheimer è la bulimia: i pazienti mettono tutto in bocca, ma non certo per fame. Lo stesso sacerdote quando comunicava i fedeli mangiava le ostie consacrate. Una delle scene più toccanti e significative per evidenziare il degrado continuo della mente di don Antonio e i suoi comportamenti sconvenienti è proprio il compulsivo cibarsi di ostie durante l’Eucarestia. Tutto si svolge in una scena di segni e ridotta all’osso rispetto alle passate rappresentazioni, come documentate dal vecchio promo su You Tube; poche cose: un tavolinetto su cui è posato un telefono, una poltrona a sacco, una grande grata a spazi larghi che si illuminano indicando vari spazi della canonica o della chiesa e dietro un grande crocifisso domina su tutto, sulla scena, su don Antonio e, in definitiva, su tutto il testo. Infatti quando don Antonio avrà dimenticato completamente di dimenticare avrà anche scoperto un rapporto più autentico con il Cristo, che sarà diventata una sorta di sua coperta di Linus. Di impatto, non solo visivo, le scene in cui il prete malato, con tanto di ingombrante pannolone, gira col Cristo in braccio e soprattutto quando gli infila i calzini sulle mani per coprirne i segni dei chiodi della crocifissione o l’accarezza teneramente e lo copre con un lenzuolo raffigurando una quasi scultorea Pietà. Non disturba per nulla la recitazione naturalistica dei tre attori sul palco. Accanto al bravissimo autore, regista, interprete Dario De Luca c’è da sottolineare l’importanza del ruolo interpretato con grande abilità da una splendida Matilde Piana, la sorella-perpetua Ricordina, che porta già nel nome, studiata e opportuna ironia della sorte, tutta la sofferenza di chi assiste malati di Alzheimer. Una sofferenza coraggiosa, ma che smarrisce e che la regia di De Luca mette particolarmente in luce per evidenziare, tra cedimenti e reazioni anche violente, il grande e “pesante” dolore di chi sta accanto a persone affette da simile patologia. Un gradino di sotto mi è parsa l’interpretazione del pur bravo Davide Fasano, un pretino tutto docile che sostituirà don Antonio, figura drammaturgicamente “leggerina” accanto alle altre molto forti. Nonostante consideri lo spettacolo intricante e da consigliare, suggerirei di rendere ancora più snelle le già brevi parti didascaliche e divulgative sul morbo di Alzheimer.
Tempodilettura.com - Simona Negrelli - 05/06/2016
Fino a che punto una malattia neurodegenerativa può sconvolgere la vita di una persona e dei suoi familiari? Difficile averne una percezione esatta dall’esterno o da un racconto indiretto. “Il Vangelo secondo Antonio” di Scena Verticale apre uno squarcio sulla quotidianità di un prete colto da Alzheimer, sulla sua esistenza inconsapevolmente devastata e quella profondamente ferita dei suoi congiunti. Lo spettacolo è andato in scena in prima nazionale a Castrovillari (Cs), al festival Primavera dei teatri, dedicato ai nuovi linguaggi della scena contemporanea e diretto dalla stessa compagnia. Dario De Luca, che ne è drammaturgo, regista e protagonista, si è ispirato a un fatto realmente accaduto al parroco di Bivongi (Rc), colpito dalla stessa malattia, divenuta manifesta alla comunità in un giorno di messa, durante la celebrazione della comunione, quando il sacerdote iniziò a ingurgitare le ostie invece di offrirle come sacramento ai fedeli. Un gesto destabilizzante, involontariamente comico e anche struggente. Ed è su questo registro che si mantiene lo spettacolo, coprodotto da Scena Verticale, Primavera dei teatri e Festival Città delle 100 Scale e giocato tra comicità lieve e vago patetismo, tra religiosità e inconscio. Dimenticare tutto è un po’ come tornare bambini, con quel misto di meraviglia di fronte a ciò che non si conosce e bisogno di essere accuditi. Regredisce all’infanzia Don Antonio, in modo tanto più straziante quanto più si confrontano gli effetti della patologia con la prima apparizione del personaggio, inizialmente attivo e brillante. Un prete di trincea in prima linea nell’accoglienza di migranti sopravvissuti a odissee marine e nel riuso dei beni sequestrati alla ‘ndrangheta. De Luca riversa nel testo anche il proprio impegno sociale e civile. Da anni, infatti, al lavoro artistico affianca quello di laboratorio, con cui coinvolge anche i disabili. Lo si vede nel dialogo telefonico tra il prete e il vescovo, in cui il secondo comunica al primo il disappunto del sindaco del paese per i nuovi arrivi di africani e il timore per il minacciato “decoro” del luogo (“Eccellenza, non si faccia influenzare da pressioni politiche meschine”). O nel diverbio tra il protagonista, nella fase iniziale del morbo, e la scorbutica sorella-perpetua, interpretata da una bravissima Matilde Piana. È lei ad accudirlo e a somministrargli quotidianamente, nonostante la riluttanza di lui, una quantità considerevole di farmaci. Che “rallentano solamente una malattia incurabile, un accanimento terapeutico”. Mentre, paradossalmente, la patologia permette a Don Antonio un rapporto più autentico e spontaneo con Cristo, staccato dalla croce, portato in braccio come fosse un figlio o una bambola o una croce stessa. Le arguzie disseminate qua e là, poi, alleggeriscono il testo e innescano una sorta di umorismo tragico. Sul palco, il terzo attore è un giovane e promettente Davide Fasano, nei panni del segretario del parroco. I tre si muovono all’interno di una scenografia (ideata da Aldo Zucco e realizzata da Gianluca Salomone) che sembra un trittico, a simboleggiare la trinità, in cui al centro sta un confessionale che funge anche da tabernacolo e altare, con in cima il crocifisso (realizzato da Sergio Gambino) e, ai lati, una poltrona e una scrivania, mentre le musiche originali sono di Gianfranco De Franco e i costumi di Rita Zangari. A volte, i personaggi danno vita a suggestive e solenni composizioni figurative, che ricordano le opere di Michelangelo. Questo di Scena Verticale è uno spettacolo (assistente alla messinscena è Maria Irene Fulco) ben costruito, in cui ognuno esprime il proprio talento, ma dall’impostazione classica, che sembra rifarsi alla tradizione del teatro popolare, dalla comicità amara e incline alla denuncia sociale, come quello di Eduardo De Filippo.
Gazzetta del Sud - Elisabetta Reale - 05/05/2016
[…] da citare il debutto dei padroni di casa di Scena Verticale con “Il Vangelo secondo Antonio”, scritto diretto e interpretato da Dario De Luca, con Matilde Piana e Davide Fasano. Don Antonio è il parroco di una piccola comunità, impegnato, attento, vive la sua vocazione come una missione ma tutto muta quando si ammala di Alzheimer. Un calvario in cui Antonio procede senza possibilità di risalita, si piega ai colpi di una malattia che diventa una croce da portare. Al suo fianco la sorella, devota perpetua Ricordina, carattere apparentemente rude, e un giovane e candido diacono. La malattia si insinuerà nella loro quotidianità piano piano. Avvolto in una nebbia sempre più fitta, Don Antonio inizia a perdere tutti i riferimenti della sua vita ma riscoprirà un rinnovato rapporto con la Croce. La religione e una malattia difficile da accettare più per chi gli sta accanto che per il malato stesso, al centro di un lavoro, coprodotto da Festival Primavera dei Teatri e Festival Città delle 100 Scale, che diventa occasione per discutere di un morbo ancora incurabile e che nel nostro Paese conta più di un milione di malati: a loro lo spettacolo è dedicato. […]
Paneacquaculture.net - Ester Formato - 11/06/2016
[…] Altro allestimento che desta una riflessione dal punto di vista stilistico è Il Vangelo secondo Antonio di Scena Verticale, spettacolo scritto e diretto da Dario De Luca che ne è anche principale interprete. In questo caso la drammaturgia è di una semplicità lineare tradotta in quadri giustapposti che narrano le fasi di avanzamento del morbo d’Alzheimer e che progressivamente priva il protagonista Don Antonio delle funzioni intellettive e poi fisiologiche. La scena è realistica, una sagrestia con pochi mobili corrosi dal tempo, dove troneggiano un grande guardaroba nel quale sono riposti gli abiti sacerdotali e due confessionali adiacenti. Un altare ed il crocifisso sono posti ad un livello superiore rispetto al piano d’assito, chiaro rimando visivo al senso religioso dei protagonisti e alla loro pia accettazione della sofferenza. Dario De Luca non sembra cercare un preciso filtro critico ma restituisce in base ad un’ottica verista la parabola di un sacerdote e la sua malattia, nuova condizione mentale che lo fa entrare tragicamente in contatto con una percezione quasi inconscia del proprio legame con il Cristo. Tra un quadro e l’altro si nota talvolta uno stacco ex abrupto,i linguaggi sono svuotati di ogni sovrastruttura a vantaggio di stilemi afferenti il contesto religioso (meridionale) in cui la fede e la stessa devozione tutta femminile per un fratello consacrato rinsaldano quotidianamente la stretta aderenza con il proprio unico destino. Sicché viene da pensare che “Il Vangelo secondo Antonio” non sia una parabola sull’Alzheimer in quanto tale, ma più che altro il racconto di come la deturpazione fisica e mentale incida sullo stesso contesto di riferimento, portando all’estremo abnegazione e rassegnazione di chi assiste Antonio, unica arma (forse necessaria) conosciuta nel confronto con la sofferenza. Solo con l’alienazione psicofisica e la perdita della dignità più elementare rivelano allo stesso Antonio un Cristo non più sacramento d’Eucarestia, concetto ormai incomprensibile per un ottenebrato da quella patologia, quanto un giovanotto da sottrarre a quella croce e sul quale trasferire le stesse minime cure di cui lo stesso prete necessità dagli altri, come flebile ribellione al dogma del dolore, incondizionato riflesso di memoria che ha dimenticato sé stessa. Di conseguenza pare che quel minuscolo mondo rinvigorito dalla devozione della sorella e da quella del giovane sagrestano – dei quali è spesso posto in luce la relazionalità, colmo ancora di tipici retaggi del sud – non possa essere raccontato onestamente se non con i linguaggi, le forme ad esso più consone e quindi con un’ottica e con alcune soluzioni registiche retoriche che talvolta potrebbero andare più in profondità, ma utilizzate con profonda consapevolezza.
Cronache della Calabria - Ilaria Nocito - 28/12/2016
“Sei quello che sei, ma non ci sei”. In una frase tutto il suo destino, il suo Vangelo. La storia della sua malattia come la canzone di Gianni Bella. Ché “all’idea della morte ci si abitua, ma come si fa con una persona cara che c’è senza esserci?”. Ché l’Alzheimer, si sa, “è bastarda, vigliacca, ti svuota dentro lasciando il guscio intatto e senza crepe”. Ché anche quando è uno spettacolo che la racconta può far male come un pugno nello stomaco. Come “Il Vangelo secondo Antonio” di Dario De Luca. In scena al teatro Morelli di Cosenza che risuona ancora di lunghi e commossi applausi davanti ad un pubblico rapito. Un viaggio tra riso e pianto quello di don Antonio, parroco di una piccola comunità del Sud, vicario del vescovo, abituato a rimboccarsi le maniche in difesa dei profughi, degli affamati, dei più deboli. Fino a quando non sperimenterà lui stesso il dolore e la solitudine della malattia dell’Alzheimer insieme alla sorella perpetua Dina (una straordinaria Matilde Piana) e al giovane diacono Fiore (Davide Fasano, di cui colpisce la spontaneità nella recitazione). Fino a quando ridotto a larva nel corpo, sarà privato persino del pensiero e della volontà ma non del cuore. Mentre perde i ricordi di una vita intera, resterà attaccato alla memoria dei sentimenti, della fede, di quel Cristo sulla croce che mai abbandonerà. Come la “coperta di linus”. Un testo forte e diretto, di ironica amarezza, raffinata originalità e una superba regia, efficace soprattutto nel rendere la potenza evocativa e poetica delle immagini, il nuovo lavoro dell’attore di Scena Verticale, di cui è autore, regista e protagonista. Impeccabile e intenso nel ruolo del prete ammalato, conquista palco e platea. Convince come la prima volta lo spettacolo, rivisto nella scenografia dopo il debutto a giugno scorso a Castrovillari per il festival Primavera dei Teatri. Ora più scarna, essenziale, segue la scena che vive e rivive nella bravura degli attori, nella loro trascinante presenza e intesa sul palco. Come da cornice alla drammaturgia il disegno di luci, nei riquadri a led che creano vari ambienti scena dopo scena. Ora una sagrestia, ora l’altare della messa, ora una camera da letto. Come una culla le musiche inedite di Gianfranco De Franco. Negli occhi degli spettatori le ostie dei fedeli ingurgitate a messa, la deposizione della croce come il Cristo che scende in terra per farsi uomo e l’inquietante voce off del medico (“togliete le chiavi dalle porte, sigillate balconi e finestre, cercatevi una badante, etc.”). La “città di Isidora”, che “ha la forma di un sogno sfuggente” come un posto remoto della mente in cui nascondere ricordi, segreti e confidenze. La notte che sembra giorno e la frase continuamente ripetuta “Dorma do’, speriamo che ti faccio dormire”. E il grande crocifisso di legno accarezzato teneramente dal don di Dario De Luca (rimpicciolito fisicamente) come una bambola, come un figlio bisognoso di cure e poi coperto, nel finale, da un lenzuolo-sudario sulle ginocchia. Come in un quadro della pietà, come le statue in un trittico. Ché “l’unica cura possibile verso l’assenza è la tenerezza”. Come una scintilla di una candela “simbolo di un amore che arriva fino alla morte”, che neanche la demenza può spegnere.
Paese24.it - Federica Grisolia - 13/03/2017
Il buio della memoria che piano piano annienta un uomo è il dramma portato in scena ieri (domenica) al teatro Sybaris di Castrovillari, dall’attore, regista e autore, Dario De Luca (co-fondatore insieme a Saverio La Ruina della compagnia castrovillarese Scena Verticale) nel suo “Vangelo secondo Antonio”,recentemente insignito del premio Tragos. Il parroco di una piccola comunità calabrese, vicario del vescovo, caparbio, brillante, sempre in prima linea per aiutare gli altri, tra tutti i migranti, viene colpito dal morbo dell’Alzheimer, trovandosi, così, catapultato in un’esistenza fatta di vuoti e medicine. Sempre al suo fianco Dina (Matilde Piana), fino ad allora la sua perpetua, che decide di continuare a prendersi cura del fratello finché ne avrà le forze. Inoltre, il giovane diacono Fiore (Davide Fasano), discepolo dei suoi insegnamenti che prenderà poi il suo posto. Tante le difficoltà quotidiane, tanto il dolore, tanta la sofferenza, a causa di una malattia vigliacca che annichilisce in maniera silenziosa e intrappola come in un guscio, rendendo incapaci di fare ciò che «anche un bambino di quattro anni riuscirebbe a fare». Una malattia che fa divenire impotenti chi ne è colpito ma soprattutto chi gli sta accanto sacrificando se stessa. Una croce tra le croci che don Antonio era abituato a portare per gli altri e a cui si aggrappa quando non riconoscerà più niente e nessuno, né la sua casa, né sua sorella Dina. E dal crocifisso prenderà Gesù Cristo – unica luce – per abbracciarlo, prendersene cura, non staccarsene mai, tenerlo sulle sue ginocchia quasi a ricordare la Pietà, in un legame trascendente suggellato poi da un lenzuolo bianco con cui coprirà la statua. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato con estrema delicatezza e sensibilità da Dario De Luca, scuote le coscienze, induce a riflettere sul senso della vita, della malattia che può piombare come un fulmine a ciel sereno, e della fede. Non casuale la scelta delle note di Gianni Bella: “Sei quello che sei, ma non ci sei”. Perché queste parole racchiudono l’intero dramma della malattia, che non strappa subito alla vita ma allontana da essa, piano piano.
Tempodilettura.com - Simona Negrelli - 29/12/2016
Uno spettacolo è come una pianta, ha bisogno del suo tempo per sbocciare. E quell’intima soddisfazione che si prova al cospetto di una fioritura può presentarsi anche quando si assiste a uno spettacolo che raggiunge la sua forma compiuta. Come nel caso del nuovo allestimento de Il Vangelo secondo Antonio di Dario De Luca, andato in scena al teatro Morelli di Cosenza. Lo spettacolo aveva debuttato la scorsa primavera a Castrovillari, al festival Primavera dei teatri, ma anche grazie a una scenografia più contemporanea raggiunge una potenza visiva che la prima messinscena non aveva. Resta invariato il plot drammaturgico dello spettacolo di Scena Verticale, scritto e diretto da Dario De Luca. Un plot di sostanza, che indaga tra le pieghe di una malattia destabilizzante come l’Alzheimer (a volte con un approccio di tipo divulgativo) per ragionare di fede e rapporti umani. L’Antonio del Vangelo, interpretato dallo stesso De Luca, è l’attivissimo parroco di Bivongi, un paesino in provincia di Reggio Calabria, alle prese con l’accoglienza dei migranti e sempre ligio al dovere. Lo aiutano nella sua missione i suoi più stretti collaboratori, la perpetua e sorella Ricordina (Matilde Piana) e il segretario Fiore (Davide Fasano). Il conclamarsi della malattia è il nodo drammaturgico che sconvolge non solo la vita di Don Antonio ma anche quella di chi gli sta intorno, rovesciando pure i ruoli: il parroco era un punto di riferimento, un uomo autorevole, si ritroverà a dover essere accudito come un neonato, con la sorella a prendere il sopravvento su di lui e il segretario a sostituirglisi e a far carriera. La perdita cognitiva di Don Antonio spariglia le carte, ma qualcosa rimane. La fede, pur perdendo i propri riferimenti razionali, resiste, magari cambia forma. Lo si vede da come il parroco inizia ad accudire il Cristo, dopo averlo staccato dal crocifisso appeso sopra l’altare. Come fosse un figlio sofferente e infreddolito. Sul palco resta poco della vecchia scenografia, classica e naturalistica. Non ci sono più la scrivania e la credenza, nel “nuovo” Vangelo un telaio illuminato di led, come una specie di parete posta al centro del palco, suggerisce i diversi spazi della scena. Sul fondo, il grande crocifisso ligneo realizzato da Sergio Gambino. I giochi di luce fanno il resto, conferendo alla scena una consistenza pittorica. Alcune scelte registiche richiamano esplicitamente l’iconografia della pittura e scultura religiosa rinascimentale. Alcune scene si concludono con gli attori come fissati in quadri e statue, a ricordare, ad esempio, la Pietà di Michelangelo. Applausi.
www.lameziaterme.it - Giovanna Villella - 05/12/2016
Una scena essenziale ma fortemente evocativa. Il perimetro scenico, quasi nudo, sovrastato da un crocifisso ligneo. Quinte nere intorno. Al centro una griglia di ferro riquadrata e illuminata a led. In questa cornice prende vita il racconto da cui è tratto lo spettacolo Il Vangelo secondo Antonio. Il libro è “La vita dimenticata” scritto da Francesca Frangipane con Amalia Bruni e Rosanna Colao (Rubbettino Editore). Una piccola raccolta, lieve ma intensa, di vissuti reali rielaborati in forma narrativa nata dall’esigenza di diffondere la conoscenza della “demenza” anche attraverso un linguaggio e una prospettiva diversi. Lo spettacolo, coprodotto da Scena Verticale, Festival Primavera dei Teatri e Festival Città delle 100 Scale è scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca con Matilde Piana e Davide Fasano. Una rappresentazione che ha per tema la malattia, l’Alzheimer nello specifico, con l’intento di squarciare (im)pietosamente i veli dell’ipocrisia e il tabù del silenzio per indurre a riflessioni interiori. Ed è proprio Scena Verticale, una delle realtà teatrali calabresi più conosciute e apprezzate nel panorama teatrale italiano e internazionale, impegnata da anni nella ricerca di una nuova drammaturgia ad usare, ancora una volta, il canale simbolico del teatro per confrontarsi con la realtà e ricordarci che i malati colpiti da patologie neurodegenerative non sono cartelle cliniche ma persone con una vita e una storia anche se non riescono più a coniugare i verbi al futuro. Grandissima prova d’attore per Dario De Luca che, nel ruolo di Don Antonio, parroco brillante e intraprendente colpito dall’Alzheimer, ci regala una interpretazione intensa e vibrante ai limiti del metamorfismo. Dalla calma lucidità con cui pianifica i suoi impegni e interloquisce con il vescovo facendo valere le proprie ragioni sull’accoglienza degli immigrati “Le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano”– unica incursione esterna concessa a una storia che è solo un viaggio interiore nelle tenebre – alla lenta metamorfosi che si manifesta con sporadiche perdite di memoria e, via via, in un crescendo tragico fino alla perdita totale di sé che porta ad una vera e propria trasformazione fisica. Le mani diventano incerte e vagano nel vuoto, le spalle si incurvano, la voce si incrina, la lingua incespica, le parole fuggono, le frasi si reiterano in un eterno loop fino allo smarrimento di senso. E le tenebre di fuori penetrano in ogni anfratto del suo corpo annullando la percezione dell’altro da sé “Signora, se ne può andare” dice rivolgendosi alla sorella, e poi le esplosioni di violenza e la regressione, con punte di amara comicità, che si manifestano in un rigoroso equilibrio di energie ora trattenute ora palesate e con atteggiamenti gestuali compendiari quasi di tutto se stesso e corrispondenti alla “realtà” (sua) che ci vuole comunicare “Ho una confusione in testa, si crea come un vortice, non so cosa fare”. E di questa “sua” nuova realtà l’unico punto fermo rimane Cristo. Cristo crocifisso che lui, in una scena dal sapore vagamente donchisciottesco, difende impugnando un candeliere a mo’ di lancia. Cristo deposto dalla croce e abbracciato, curato, cullato, coccolato con amore filiale “Lui è il mio vero Padre”. E ancora la scena del ballo sulle note di “Sei” di Gianni Bella fino al tableau finale della “Pietà”, illuminato da un taglio di luce quasi caravaggesco, con il Cristo in grembo coperto da un bianco lenzuolo di lino, dono del suo ex diacono Fiore nella misurata e convincente interpretazione di Davide Fasano. In questo “candore senile” che cancella ogni limite spazio-temporale “Ma perché ogni sera cambiamo casa?”, Antonio conduce la sua vita al passato remoto curato dalla sorella Dina. Dina/Domandina, interpretata con grande sensibilità da Matilde Piana, ci introduce nell’universo sofferto e sofferente dei familiari che assistono i malati di Alzheimer. E così Dina dalla rigida incredulità nella scena con la dottoressa (fuori campo) che le spiega cosa fare “Nascondete il Vernel. Colorate la porta del bagno. Mettete un cartello rosso sul water e un tavoletta sul bidet…” ci offre il suo umano calvario fatto di rifiuto, rabbia impotente, esasperazione, fragilità, smarrimento. Poi arriva il rimpianto di aver perso una persona amata e la difficoltà di dover costruire con lei un rapporto completamente nuovo, in solitudine “Questa malattia ti svuota e lascia il guscio intatto”. E ancora la rassegnazione senza più domande, la compassione, nel senso etimologico di partecipazione alla sofferenza dell’altro e, infine, l’amorevolezza. Amorevolezza, per usare una parola tanto cara a Don Bosco. Amorevolezza che non è solo l’estensione lineare della parola Amore già in essa contenuta ma presuppone soprattutto tenerezza, dolcezza, gentilezza e fa rima con carezza… “Malattia incurabile. Ha il nome di un cacciabombardiere tedesco che spara missili e lascia crateri” dice Dina, ma lei è là, accanto a lui a coprire questi “crateri” con parole pazienti, ad accudirlo e a nutrirlo fino all’annullamento del suo essere donna. Adesso è lei a portare quella croce che secondo il Vangelo di San Marco “[…] è il simbolo dell’amore che arriva fino alla morte. Dio è presente nella sofferenza di ciascuno di noi e verrà il giorno che asciugherà ogni lacrima”. Bravi tutti. Applausi e ancora applausi.
Giornale di Brescia – Prof. Marco Trabucchi – 02/04/2017
Ho recentemente assistito nel teatro di Sarezzo ad una rappresentazione intensa e commovente, «Il Vangelo secondo Antonio» della compagnia «Scena Verticale». La storia di un sacerdote che vive tutti i drammatici momenti della demenza di Alzheimer, dai primi segni fino alle fasi finali. Spettacolo che ha lasciato un segno forte anche in chi scrive, perché l’arte, quando raggiunge certi livelli, è in grado di trasmettere sensazioni e di scoprire angoli bui, dove la clinica raramente riesce ad entrare. In questa pièce, l’arte si unisce alla scienza, perché il testo ha avuto la supervisione di una delle realtà italiane più avanzate per la ricerca sulle demenze, il centro di Neurogenetica di Lamezia. In scena vi sono tre bravissimi attori, il protagonista, di straordinaria efficacia nell’interpretare la propria drammatica evoluzione personale all’interno della malattia, sua sorella che ha dedicato la vita al proprio caro e che non riesce a comprendere fino in fondo gli avvenimenti, un giovane sacerdote, che assiste stupito e impotente, ma sempre adeguato, al progredire della malattia del confratello più anziano. È stato un viaggio nella vita, perché la malattia è purtroppo spesso presente nelle nostre comunità, un viaggio nel dolore, perché don Antonio soffriva molto, un viaggio nella malattia demenza, descritta con profonda sensibilità, un viaggio nella religiosità, fatta di sofferenza, di fatica, di impegno.
Psicogeriatria, n. 3 – 2016 rivista di neuroscienze – Dott.ssa Luisa Bartorelli
[…] Nello scenario di fondo, semplice e rigoroso, don Antonio si muove confuso proiettando sul grande crocifisso la sofferenza che li accomuna, fino a staccarlo dalla croce per tenerlo con sé e a sua volta prendersene cura. […] Le persone che assistono allo spettacolo, siano esse neutrali, oppure ferite in famiglia dalla malattia o, ancor più, gli addetti ai lavori, rimangono col fiato sospeso davanti alla complessità della rappresentazione. Infatti tante scene forti e ben delineate tengono in tensione il pubblico in una partecipazione appassionata, che finalmente esplode nel lunghissimo applauso finale. Anche la scena che conclude la storia, sicuramente ispirata al tempo della misericordia, è geniale nella sua rappresentazione: il lenzuolo di lino che avvolge la persona sofferente insieme al Cristo, in mezzo ai suo Giovanni e Maria, come in una pietà fiamminga.
Prealpina – Federica Lucchini – 02/09/2017
L’Alzheimer fest, l’evento a carattere nazionale, ha avuto un “antipasto” di teatro al Teatro Duse di Besozzo con lo spettacolo “Il Vangelo Secondo Antonio” […] che ha incantato il pubblico presentando la vicenda di un parroco affetto da Alzheimer: cruda, intensa. […]