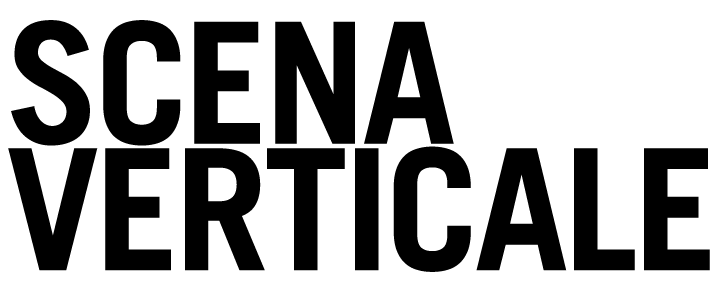Scena Verticale
la Repubblica Tutto Milano – Franco Quadri – 21/01/2010
U Tingiutu, Aiace e la mafia.
È fiorito un assieme d’attori – autori formidabile nella collinosa Castrovillari grazie a Scena Verticale, un gruppo calabro assai creativo che ospita un prezioso festival teatrale del Sud come Primavera dei Teatri, vince premi, gira il mondo. E dopo il successo di Saverio La Ruina è ora il turno di Dario De Luca, l’altro capogruppo, a distinguersi e presentare anche in tournée come scrittore, regista e interprete il suo U Tingiutu, ovvero il Tinto, storia di un mafioso colpevole di sgarro e condannato. Ma la novità rispetto alla tradizione sta nell’aver modellato l’azione sulla storia antica di Aiace con precisi riferimenti alla tragedia greca che ben si adattano agli odierni costumi della ‘ndrangheta anche se sorprende sentir ripetere i nomi dei mitici eroi davanti al corpo steso del condannato monologante, separato dal pubblico da una tapparella – sipario con una tecnica molto efficace che evoca a sua volta una magica espressività cinematografica.
l’Unità – Maria Grazia Gregori – 06/06/2009
Aiace contro la ‘Ndrangheta.
[…] U Tingiutu spettacolo scritto, messo in scena e interpretato da Dario De Luca e da quattro bravissimi attori. […] ci parla di ‘ndrangheta, di sgarri da pagare con la vita, di torture e di sangue. Il titolo illumina questa realtà inquietante e violenta: “tingiuto” è chi porta su di sé il segno del tradimento, chi ne è “tinto” Una vittima predestinata, un morto che cammina. Per raccontare questa storia che si svolge all’interno di un’impresa di pompe funebri dove i cadaveri sono all’ordine del giorno, De Luca sceglie la tragedia greca, conferendogli però una forte connotazione popolare. I nomi che tutti conosciamo – Achille, Ulisse, Aiace, Menelao, Agamennone – sono così tolti alla loro aura mitica e inseriti in una losca realtà di lotte fra clan per un potere parallelo e criminale che trova la sua stessa linfa in quella “contiguità” in cui mafiosi e non mafiosi, assassini e gente onesta vivono gomito a gomito in un clima in cui tutto si corrompe. Uno spettacolo, dunque, che pone la necessità di un’educazione anti mafiosa come unica fonte di una libertà vera, lontana dalla paura. In scena intanto la violenza e lo scempio dei corpi, la loro identità negata assumono una forza incredibile dilatata dal dialetto, dai rituali delle torture, magari scandite dalle canzoni di Pupo, che trasformano la disputa antica fra Ulisse e Aiace Talamonio per le armi di Achille, in un contrasto senza scampo che ha come posta il potere, la vita stessa. Impressionante è il silenzio carico di tensione del pubblico e l’applauso liberatorio a ogni buio, a ogni mutare di scena.
Delteatro.it – Maria Grazia Gregori – 08/06/2009
da Primavera dei Teatri – Resoconto sul festival
[…] Quest’anno il cuore pulsante del festival è sembrato essere lo sguardo profondo, “politico” – nel senso che riguarda la nostra vita qui e ora -, sul nostro oggi. Lo si può rintracciare in una storia di violenza e degrado sia pure trasfigurata dal riferimento alla tragedia classica come l’importante U Tingiutu di Scena Verticale dove Dario De Luca racconta una storia di ‘ndrangheta fra sgarri e rituali di violenza per possedere il potere assoluto, cioè il diritto di vita e di morte su tutti partendo dalla mitica vicenda dell’odio fra Aiace e Ulisse per il possesso delle armi di Achille. […]
il Manifesto – Gianfranco Capitta – 07/06/2009
Quel mito senza gloria segnato dalla mafia.
[…] Tra i numerosi titoli, un’attenzione particolare va ai padroni di casa di Scena Verticale: Dario De Luca, autore, attore e regista, ha dedicato al problema più grave della sua terra, la malavita organizzata, una sua particolare rilettura, cinematografica e pulp, di uno dei miti più oscuri e infelici del mito troiano. U Tingiutu. Un Aiace di Calabria, traspone infatti il mito del Telamonio dagli accampamenti achei intorno a Troia, nella sede di un’agenzia di pompe funebri dei giorni nostri, laboratorio indefesso di spaccio d’eroina e di regolamenti di conti esiziali dentro la cosca. Aiace predestinato alla sconfitta, nel senso di infelicità e di morte, perché a lui viene preferito Odisseo, equivale al perdente dentro le gerarchie mafiose, quello segnato (appunto “tingiutu”) votato a una fine senza gloria. Ma la ricostruzione del mito individua gli affiliati indaffarati a fare il proprio lavoro di necrofori o peritisettori. L’andatura è davvero quella del film noir, con dei frequenti flashback che ne movimentano la drammaturgia, e progressivamente danno indizi alla ricostruzione del puzzle che all’esterno prenderà le forme composte di un funerale per cause violente. Ma i rapporti tra gli uomini, i gesti e i saperi di ognuno (preparare le dosi o acconciare la salma) si intrecciano lungo una certa orripilata suspence, non per un preconcetto moralismo, quanto per il dolore, e la violenza e l’impotenza, che quei rapporti scoprono. Dietro una parete di tende alla veneziana che rendono bene la discrezione dell’omertà, lo spettacolo (con gli attori intensamente impegnati e il ritmo da commedia nera) diventa un percorso conoscitivo molto diverso dalle fiction tv sull’argomento.
la Repubblica Trova Roma – Rodolfo Di Giammarco – 10/03/2010
Finalista del Premio Riccione 2009, questo testo tragico, feroce, neorealistico e anche oscuramente metaforico ritrae una storia di cosche mafiose meridionali attraverso una rilettura da epopea greca, mettendo in scena una lotta mortale tra clan associata ad un’impresa di pompe funebri, con un gangsterismo vissuto come mito luttuoso, con l’ombra di eroi greci per ambizioni e destini da malacarne.
Hystrio – Andrea Nanni – luglio / settembre 2009
La famiglia, ultimo tabù
[…] Una mala famiglia per eccellenza, una cosca unita dal crimine e non dal sangue, è infine quella di U Tingiutu. Un Aiace di Calabria che Dario De Luca tratteggia affondando la tragedia sofoclea in una quotidianità malavitosa scandita da successioni sanguinose nel retrobottega di un’agenzia di pompe funebri. Ricostruito cinematograficamente come un lungo flashback, il mito degradato ci parla con un dialetto gergale che più di ogni altra cosa racconta la miseria di un’onorata società pronta a nascondere dietro la tracotanza un’insanata povertà di affetti, come suggerisce la struggente invocazione alla madre che Aiace pronuncia prima di uccidersi. Con ritmo serrato e recitazione affilata, questo affresco ruvido e dolente conferma, al di là della pluripremiata prova solista di Saverio La Ruina in Dissonorata, la maturità di Scena Verticale, capace di restituire con davvero tragica lucidità i lati più oscuri del nostro Sud.
la Repubblica Milano – Sara Chiappori – 29/01/2010
La mafia in scena senza retorica
Si chiamano come gli eroi greci, ma sono gli affiliati di un clan della ‘ndrangheta. Il boss Achille è morto, al suo posto è stato scelto Ulisse. Aiace non ci sta: convinto che l’onore della successione spetti a lui, sceglie la vendetta. Sapendo che questo farà di lui il tinto, ovvero il condannato a morte. Con U Tingiutu, di cui è autore, regista e interprete con Rosario Mastrota, Enresto Orrico, Fabio Pellicori e Marco Silani, Dario De Luca di Scena Verticale dimostra che si può parlare di mafia senza cadere nella didascalia. Il suo spettacolo è un oggetto teatrale multiforme che travasa la tragedia greca nella tragedia contemporanea della sua terra tra morti ammazzati, fiumi di sangue e chili di cocaina. Epico nella lingua (un dialetto arcaico che è insieme postura fisica, sguardi e silenzi), cinematografico nell’impianto con omaggio esplicito a Tarantino, sofisticato per la drammaturgia che procede per salti di tempo, acuminato nella recitazione che si concede deviazioni grottesche. Efficace la concezione dello spazio: il retro di un’agenzia di pompe funebri separata dalla platea con una parete di veneziane che ben allude all’atteggiamento omertoso.
Carta n. 23 – Graziano Graziani - 2009
Aiace, una storia d’onore calabrese La compagnia Scena Verticale torna a parlare di sud con uno spettacolo scritto e diretto da Dario De Luca, ma questa volta attorno ai temi della malavita calabrese. «U Tingiutu» per la ’Ndrangheta è una persona tinta col carbone, segnata, perché destinata a morire. Come il protagonista di questa storia che riscrive il dramma classico di Aiace nella cornice di una vicenda di mafia, conservando i nomi dell’epopea omerica. La ribellione di Aiace alla decisione di Agamennone di preferirgli Ulisse, allora, diventa la cornice in cui si muovono facce del sud, con le loro voci e le loro gestualità intrappolate nella cultura mafiosa, che le sovrasta carica di quell’imprescindibilità che aveva il fato per gli achei. A testimoniare, come afferma De Luca, che la contiguità tra chi vive in un contesto mafioso e chi lo rifiuta può pesare come un macigno, come una predestinazione. E non a caso tutta la scena di «U Tingiutu» – testo finalista al Premio Riccione di quest’anno – si svolge dietro una fila di veneziane abbassate, che in parte nasconde ciò che avviene. È una storia vista e non vista quella di Aiace che sceglie il suicidio per mantenere l’onore e vendicarsi di Ulisse; è qualcosa che tutti sanno ma nessuno è riuscito a guardare. Una scelta fortemente evocativa, in grado di proiettare l’azione in una dimensione filmica che è in fondo il leitmotif della piéce, montata secondo logiche cinematografiche, a salti temporali, che strizza l’occhio ai film di Tarantino. Ed è qui il rovescio della medaglia, nello stile dei mafiosi di provincia che ricorda i film di Al Pacino, dove però si innesta perfettamente il dialetto calabrese, il kitsch sguaiato che si commuove per le canzoni di Pupo e si offende per i doppi sensi del testo di Malgioglio, l’ironia pesante della provincia. Come a dire che anche loro, gli uomini d’onore che non si fanno comandare da nessuno, hanno in realtà un destino cucito addosso, una maschera di cui non possono fare a meno. In definitiva, una serie di scelte obbligate. I linguaggi del cinema trapiantati in teatro rischiano di essere un’arma spuntata, dal retrogusto posticcio, un diversivo estetico. Ma la scelta di De Luca è di tutt’altro spessore; al centro di «U Tingiutu» c’è la tragedia, nell’accezione più classica, e i riferimenti al montaggio non fanno altro che esaltarne in chiave moderna l’ineluttabilità. Complice anche la recitazione di Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori e Marco Silani, che con De Luca dividono la scena.
Altre Velocità – Lorenzo Donati – giugno 2009
Altro discorso va fatto per l’efficace U Tingiutu di Scena Verticale, scritto diretto e interpretato da Dario De Luca insieme a un affiatato gruppo di attori. Un Aiace di Calabria recita il sottotitolo, e il parallellismo si attesta anche qui su un registro di immediatezza: come Aiace e Ulisse di Sofocle erano in litigio per ereditare le armi di Achille, qui due malavitosi si scontrano all’interno delle dinamiche di un clan calabro. I codici scelti da De Luca, pensiamo con estrema lucidità, occhieggiano a un certo cinema d’ascendenza tarantiniana: i mezzi del teatro (buio – luce – buio) rivedono i meccanismi della dissolvenza cinematografica, con molti stacchi sonori a fungere da ponte tra una scena e l’altra. Dalla stanza di un obitorio, sede di loschi traffici e commerci illegali, passiamo allo stesso luogo ma con altri personaggi – Aiace e Ulisse alla resa dei conti – in cui l’uno ha rapito l’altro prima dell’epilogo finale. In aggiunta, proprio come in Jackie Brown di Tarantino, continue analessi e prolessi rompono i piani temporali, e lo spettacolo si conclude con la stessa scena che avevamo visto all’inizio: il conflitto porta a una risoluzione tragica, che De Luca sceglie di anteporre a tutto, sezionando i meccanismi anche narrativi che la producono, riavvolgendo il nastro in cerca di inceppamenti e vuoti di senso forse in grado di produrre un cambiamento. Anche la recitazione ha un certo ascendente filmico, spostata su un tono gangsteristico che privilegia l’esteriorità del tipo, dal capobanda Agamennone al gregario un po’ schizzato. La scelta è quindi chiara, e per questo funziona. Entrati dentro alla convenzione, assunta la grammatica del codice, ci accorgiamo che De Luca va a scavare sotto alla violenza, sotto ai meccanismi che la generano e che la rendono tutto sommato “accettabile”. Nessuno che si ribelli al divieto di seppellire Aiace, “macchiato” dal clan per avere disobbedito, eppure uomo giusto e valoroso. Nessuno che intervenga, che racconti quello che ha visto. Anche noi stiamo lì a spiare, dalle fessure di veneziane che calano all’inizio sul proscenio. Nessuno che provi a far divenire questi moderni “eroi” un po’ meno di quello che sono, per far decadere la loro aura, il loro potere intoccabile. Lo ha fatto De Luca raccontandoli in modo “epico”, ma allo stesso tempo instillando dubbi, spingendo su una sorta di “identificazione interrotta” in cui col procedere della storia aumentano anche le domande su quanto stiamo vedendo. Forse, queste domande che l’opera ci pone, potranno essere ancora precisate e in un certo senso approfondite, soprattutto nel rapporto fra l’altisonanza dei nomi greci e la magnetica meschinità dei personaggi, così precisamente attaccati a questa “italiana” Calabria di oggi.
Scanner.it – Tommaso Chimenti – 17/06/2009
L’impasto torbido al sapor meridionale straborda come salsa da un panino mangiato con troppa foga, con quella smania di vita che fa collimare l’esistenza alla sua stessa perdita. Chiamala morte. I valori ed i principi, la rispettabilità, la testa alta, la dignità, allineano il lignaggio classicizzante (sicuramente forzatura dei contemporanei) della Magna Grecia a questo Sud che vive di fievoli ricordi sbiaditi tra “uomini d’onore” dove il sangue è il legame più forte. Un Aiace moderno, tinto dalla ed imbevuto nella colpa, Dario De Luca, molto “Scarface”, che dirige anche Scena Verticale in questa nuova produzione segnalata al Premio Riccione, corroso da quel potere-rispetto mai conferitogli, discioltosi nelle recriminazioni e nei presunti torti subiti in ambito familiare in un’analisi a ritroso sui propri trascorsi rapporti edipici conflittuali, assetato di vendetta e affamato di farsi giustizia a tal punto da rapire Ulisse (in una scena che ricorda “Le iene” tarantiniane con un body check otorino da Tyson versus Holyfield) ma, dopo avergli vomitato la sua rabbia disperata lasciarlo ancora libero e vivo, pronto a poterlo colpire a piacimento. In un’atmosfera da “Gomorra” suona il kitsch (“Hamlet”) di un Pupo d’annata. Se Aiace ne esce comunque sconfitto, punendosi con un atto estremo che non rientra nel codice meridionale ma che anzi ricorda l’harahiri orientale, anche Ulisse risulta un personaggio senza nerbo, senza spada, senza parole. Piccoli mafiosi (c’è l’odore di “Acido Fenico” dei Koreja), gangster provinciali che spoetizzano e “ripuliscono”, finalmente, dal mito eroico e d’epopea anche Menelao e Agamennone umanizzandoli, boss caricature di se stessi in continui giochi di forza, sottomissione e zuccherino, gerarchie ritualizzanti tra galli nel pollaio, scontri da capobranco mignon. Ancora bare in scena come in “Pop Star” dei Babilonia Teatro. Il calabrese continua a tagliare, ferire, far male. Ad una prima parte nel segno di una comicità involontaria segue una parte centrale corposa e densa come epo nelle vene di un ciclista in salita. L’intuizione-invenzione della veneziana-tapparella che cala dall’alto a rendere un velo di vedo-non-vedo al pubblico fa da binocolo scannerizzando e segmentando la scena, è un atto d’accusa alla platea-popolo ed alle sue persiane abbassate omertose, a quel senso di liberazione catartica, a quell’alibi del non ho potuto vedere perché la visuale mi era coperta. Chiamala “non è colpa mia”. Le sequenze a flash back prevedono quadri di stampo cinematografico con andate e ritorni, montaggio da celluloide che è quasi un agguato. Il Padrino sta nel tuo stesso pianerottolo. Voto 7
Sipario – n. 718/719 – Claudio Facchinelli - 2009
[…] U Tingiutu. Un Aiace di Calabria, di cui Dario De Luca firma il testo e la regia, una rilettura in ambiente mafioso delle vicende che legano alcuni personaggi della tradizione omerica, è un lavoro ambizioso, di forte impatto spettacolare, che nasce da un’accurata ricerca diacronica sui dialetti calabresi, dalla quale scaturiscono le scelte di registro verbale. […] Peraltro, la scelta linguistica non è un elemento folcloristico aggiuntivo, ma è parte integrante di un’operazione culturale, che risulterebbe impoverita, se non stravolta, da una rinuncia al gioco cromatico del dialetto (anzi, dei dialetti). Magari, un giorno riusciremo ad assistere ad una versione sottotitolata, come si fa, anche in Italia, con le produzioni straniere, per cogliere appieno i sapori arcaici di questa intrigante trasposizione contemporanea. […]
Teatro e Critica – Simone Nebbia – 01/04/2010
[…] U Tingiutu. Un Aiace di Calabria è uno spettacolo straordinario che sa dire, di questa terra, i mali e la sorte. […] Uno degli elementi più forti è la coralità linguistica che fa da sponda a una drammaturgia asciutta, lineare, che non esce mai dagli argini protettivi ma, proprio grazie alla solidità linguistica, non difetta mai di attrazione. Il coro di una lingua che è musica – dato che ho più volte evidenziato nel caso di questo gruppo calabrese – è un rito nel rito della morte, un doppio filo che aumenta la percezione della fatalità. L’asettica estraneità mentale dell’azione è la chiave di questo spettacolo: la morte in primo piano, sullo sfondo la confusione degli uomini, distratti dal loro incontenibile declino. L’evoluzione di questo naufragio è come un percorso a ritroso, dal letto freddo di un’anticamera mortuaria, fino a ricostruire la sequenzialità inappellabile della morte. Decisamente rilevante per la coralità è anche la forma di attori straordinari – oltre a De Luca, Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori, Marco Silani – e l’uso della luce e delle musiche, così come del velo-sipario, in funzione di atmosfere tese e mai vacillanti. La prima parte dello spettacolo è in luce, la seconda è velata perché chiara è la morte, oscuri i percorsi che vi conducono. La struttura è di una precisione secca e coerente alla tragedia; l’inizio illude: tre quadri iniziali, in mezzo la morte adulta, a sinistra la morte infantile, a destra gli strumenti con cui si affrontano entrambe, nella frivolezza di un alberello di natale dorato e una radio che trasmette canzonette popolari. Poi tutto muta e si fa prologo, gli eventi spingono dentro la vita di una famiglia criminale: ecco allora il nodo drammaturgico più forte, il passaggio di stato è percepito come inevitabile, legato a una deriva: è qui che la tragedia mostra la sua asciutta specularità al testo sofocleo, la sua dipendenza da sé stessa, giro vuoto di altre esperienze, che ne riconosce una soltanto, per sé vitale, e insieme mortale.
Italia Sera – Chiara Merlo – 10/03/2010
L’Aiace di Sofocle messo in scena come speranza, seppure non apparente. Forse perché inorridire è sperare. Agghiacciante fotografia del reale che sfrutta le luci meste e quiete del crepuscolo. Una simbologia di scena spietata e fredda: le veneziane abbassate come fessure prospettiche sulla scena del crimine, dove più e più volte vengono ripetute le uccisioni barbare, gli scannamenti senza brividi, in sequenza, a strisce, a fettine dentro ai tuoi occhi. Obitorio. Feritoie dietro le quali nascondersi, ma non del tutto…davanti, attoniti spettatori. Una distanza subdolamente fittizia. Un noir crudele, nel linguaggio stretto del dialetto calabrese. […] Una regia clinica, senza concessioni allo spasmo, una vivisezione precisa dove ogni taglio deve essere netto, perciò drammaticamente senza dolore. Il testo è complesso, fatto di rimandi e sovrapposizioni simboliche. Un testo antico trascritto in dialetto primitivo. E per questo, finanche più esauriente. Gli attori sono eccezionali, caratterizzati al meglio, morti e fantocci compresi. Una dinamica serrata che non lascia spazio a obiezioni. Veniamo letteralmente brutalizzati senza avvertimento. E di colpo scaraventati dentro a quelle bare aperte che, seppure ancora senza coperchio, di più sono opprimenti. Assolutamente di pregio l’opera drammaturgica di Dario De Luca, nella misura in cui si fa feroce ed aberrante.
www.renatogabrielli.it – Renato Gabrielli – 29/01/2010
Cadaveri e fantocci
Lo spettacolo di una morte spogliata di qualunque sacralità o aura tragica è al centro di U Tingiutu. Un Aiace di Calabria, in scena al Teatro ì di Milano fino al 30 gennaio. La compagnia calabrese Scena Verticale riesce ad evocare la violenza di un conflitto all’interno di una cosca criminale dei nostri giorni, operando un doppio spostamento: accosta a quella dell’Aiace sofocleo la parabola di un boss tingiutu, “segnato” a morte sicura per la propria insubordinazione; e cita, nel montaggio drammaturgico e nella caratterizzazione dei personaggi, uno stile da gangster movie. Assieme all’uso efficace di un dialetto che alterna felicemente un registro poetico a un altro più quotidiano e degradato, questi due accorgimenti consentono all’autore e regista Dario De Luca di creare una tensione fredda, straniante, in cui non c’è spazio per alcuna empatia del pubblico nei confronti dei criminali protagonisti della vicenda. La violenza è stilizzata, raggelante. Il parallelismo con la tragedia greca marca soprattutto una distanza incolmabile: non c’è nulla dell’antico ethos eroico nell’”onore” di cui parlano questi Aiace, Ulisse, Teucro, Agamennone, Menelao – i cui nomi stessi risuonano incongrui nel flusso della parlata dialettale. L’insulto al cadavere, tabù che in Sofocle si tenta invano di infrangere a fine tragedia, qui è il punto di partenza. L’intera azione si svolge in un negozio di onoranze funebri, dove, nella potente scena d’apertura, quattro necrofori si danno a un macabro cazzeggio intorno al corpo di Aiace. Nel mondo descritto da Scena Verticale (il nostro), la morte può diventare impunemente oggetto di un disprezzo sadico; dopo essere caduti in una sparatoria, i corpi degli attori risultano così intercambiabili con dei fantocci. Non c’è moralismo, ma una messa in questione del nostro sguardo assuefatto alla violenza, in questo lavoro che deve la sua riuscita anche alla recitazione asciutta, e davvero ammirevole nelle scene d’insieme, dei suoi cinque affiatati interpreti. Da segnalare infine il libretto, pubblicato dall’editore Abramo, che contiene oltre al testo un prezioso saggio introduttivo di Gerardo Guccini.
Eolo.it – Mario Bianchi – 10/06/2009
da Primavera dei Teatri – Resoconto sul festival
[…] Si diceva di spettacoli del Sud ed intorno al Sud, molti ed interessanti che, finalmente orfani delle suggestioni di Emma Dante, ci hanno offerto prospettive e suggestioni inconsuete e diversificate a cominciare dal nuovo spettacolo di Scena Verticale, scritto e diretto da Dario De Luca. De Luca in U Tingiutu, riscrive l’Aiace sofocleo ambientandolo nel mondo della ‘ndrangheta calabrese, qui alla morte del boss Achille, Agamennone, il capobanda, sceglie Ulisse e non Aiace come affiliato più valoroso e gli attribuisce il potere del capobastone morto. Aiace, offeso nel suo onore, stermina i sui giudici e tortura il rivale, diventando così per tutti “ nu tingiutu”, il segnato, condannato per lo “sgarro” eseguito ad essere un morto che cammina. Tutto lo spettacolo metaforicamente si svolge in una agenzia di pompe funebri da dove, attraverso una veneziana appena socchiusa, il pubblico può assistere agli eventi luttuosi. E’un mondo senza speranza quello che a fatica ma nello stesso tempo nitidamente si intravede, un mondo fatto di violenza e di vendetta dove la pietà non può aver posto. Il tutto messo in scena come un noir contemporaneo, impastato con una lingua misteriosa, un dialetto che varia da personaggio a personaggio, come variano nei frequenti flashback i punti di vista, sempre però nell’ambito di un mondo che non conosce il perdono e che la metafora tragica ci rende perfettamente. [..]
Krapp’s Last Post – Simone Pacini – 10/03/2010
L’Onorata Società calabrese nel noir di Scena Verticale
Stupisce la maturità artistica di Dario De Luca, attore, regista e autore di Scena Verticale, compagnia calabrese che si è imposta da qualche anno a livello nazionale. Nel suo recente “U Tingiutu. Un Aiace di Calabria” (2009) la protagonista assoluta è la “Mala Calabria”, la ‘ndrangheta, che viene declinata nelle sue più bieche oscenità: la brama di potere, la violenza, il delirio. […] La struttura narrativa, agile, ricca di flashback e costruita in forma circolare, è supportata dall’interpretazione dei favolosi attori, che vale la pena citare tutti: oltre a Dario De Luca, Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori e Marco Silani. Camaleontici e precisi si muovono come felini in scena, sputano la loro rabbia e ingannano il pubblico, visto che nel finale sembrano almeno il doppio. La lingua calabrese, dura quanto basta, trasmette tensione e racconta di come la ‘ndrangheta si regga sui rapporti di famiglia: vincoli che sembrano importanti, ma che in realtà contano meno di una “pippata in più” e del potere. Nessun onore quindi, come nessuna speranza, ma solo pistole in bocca e torture, prevaricazioni e violenza continua, in un crescendo di ambientazioni noir che vivono di chiarori e ombre in stile cinematografico, con le luci tagliate dalle veneziane, capaci di creare un paesaggio insano e buio che getta nello sconforto gli spettatori. Lo spettacolo arriva diretto al pubblico romano, superando il dialetto e riuscendo a far vibrare gli episodi narrati, così da rendere questo mondo troppo vicino a noi.
MarteMagazine – Christian Auricchio – 10/02/2010
Ammetto che leggendo la presentazione dello spettacolo ero rimasto piuttosto perplesso: spesso quando si parla di piece che traggono spunto dai dei classici, si assiste a rappresentazioni che sono solo il pallido riflesso dell’opera originale. Fortunatamente (per me) U tingiutu è stata una bella sorpresa, mettendo in scena una tragedia con una trama da thriller che strizza l’occhio al cinema di matrice tarantiniana: i mezzi del teatro (buio – luce – buio) ricordano infatti i meccanismi della dissolvenza cinematografica, con molti stacchi sonori a fungere da ponte tra una scena e l’altra. Ma la scelta scenica che ho maggiormente apprezzato è stata quella della veneziana – tapparella che crea in platea un azzeccato vedo non vedo, richiamando, credo volutamente, le omerose persiane abbassate che possono osservarsi in parecchi paesi del Mezzogiorno di fronte ai delitti più efferati commissionati dalla criminalità organizzata. A rafforzare la credibilità del lavoro di De Luca provvede anche l’utilizzo del dialetto calabrese, che non è un mero elemento folcloristico, ma risulta essere parte integrante della narrazione. Tutti questi elementi danno allo spettatore la sensazione di assistere ad un film neorealista, dove non ci sono eroi, ma solo fatti, purtroppo sempre tristemente attuali.
Nonsolocinema.com – Marianna Sassano – 18/06/2009
‘ndrangheta ed epica, lo stesso delirio U Tingiutu è una trama da thriller.
Con il mistero dell’intreccio, i singulti della paura, lo scanto di un rumore. U Tingiutu tiene col fiato mozzato mentre mostra uomini che vestono i morti, uomini che parlano d’onore, uomini che staccano a morsi le orecchie di altri uomini. Uomini che leccano la coca come i cani dalla ciotola lasciata in giardino; uomini che danno ordini, uomini che li accettano. U Tingiutu è un thriller innanzitutto perché c’è il morto e di quel morto c’è da sapere qualcosa. E poi perché c’è il gioco della psiche da comprendere, ci sono le dinamiche della violenza da accettare, da apprendere come elementi narrativi, con la lucidità del detective. Ma la parte dell’indagatore la fa il pubblico: sulla scena non c’è spazio per i buoni, non c’è redenzione. Perché questa è storia di ‘ndrangheta. A raccontarla, in prima nazionale al festival Teatri delle Mura di Padova nel ventre già cupo del Bastione Alicorno, i calabresi di Scena Verticale, a far seguire gli Ubu conquistati nel 2007 con Dissonorata. Uno spettacolo, scritto e diretto da Dario De Luca, che esplora le dinamiche di una famiglia malavitosa all’indomani di un comunissimo sgarro. Da far pagare con la vita al tinto – tingiutu, appunto – di turno. E allora la storia degli uomini torna indietro di mille e mille anni. I nomi dei personaggi sono i nomi degli eroi: Aiace, Agamennone, Ulisse, Menelao. La lotta tra gli uomini è lotta intestina, ora come allora. E anzi, sembra dirci De Luca, la lotta degli uomini svuota del mito persino la lotta degli eroi, che tornano meschini. “Passano gli anni e la storia si ripete”, per usare le parole di Enzo Biagi; ma c’è anche dell’altro: il sospetto sotteso che la natura dell’uomo sia immutabilmente animale. Con momenti di tesissima e sospettosa leggerezza (molto ben articolata la scena d’apertura, con l’irruzione della musica di Pupo “che lo facciamo venire per la festa della Madonna”) la storia è tutta ambientata in una agenzia di pompe funebri. Una cornacchia sulla bara stempera la tensione, così come i costumi: tamarri, fuori moda, indietro nel tempo. Come questo micromondo, con crocefissi da baciare e pistole da puntare alla testa “per ubbidienza”. Eppure. La forza con cui Dario De Luca, Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori, Marco Silani interpretano U Tingiutu è notevole. Una forza violenta e lucida, che urla “guardate come sono, sembrano uno stereotipo, sembrano una barzelletta ridicola, e invece sono veri”. I personaggi che si alternano sul palco sono credibili: e sono credibili gli sguardi, le voci, i volti degli attori. Sono credibili i dialoghi, le parole in dialetto, sono credibili i gesti, le torture. Sono credibili la disperazione e la vendetta, sono credibili la crudezza e il calcolo. Uno spettacolo che affronta con grande consapevolezza artistica ed espressiva “l’importanza di un’educazione anti-mafiosa”, riprendendo le note di regia; e che riconferma, se mai ce ne fosse bisogno, la natura intrinsecamente sociale del fare teatro.
Aprile online – Erica Bernardi – 19/10/2009
Se solo mamma mi avesse regalato un pigiama: genesi di un malavitoso “Noi viviamo in Calabria. Castrovillari è un’isola felice, ma c’è comunque ndrangheta. Nei nostri atteggiamenti e nella nostra forma mentis abbiamo questa cosa. Nessuno tratta questa piaga. Io personalmente volevo trovare un modo per parlarne senza essere retorico” così Dario De Luca, in un’intervista alla fine dello spettacolo, ci spiega i presupposti alla base del suo lavoro. “Un giorno mi sono ritrovato tra la mani l’Aiace e mentre lo stavo leggendo mi sono detto: questi parlano come i calabresi!”. La sfida di De Luca è quella si riuscire a rendere una storia nota (qual’è quella d’Aiace) in qualcosa di comunque nuovo e sorprendente per lo spettatore: “non lo so se sto qui o se ritorno tra poco” sentiamo alla radio, decidiamo però tutti di restare lì, nel nostro essere colpevoli, dietro quella persiana. Noi che vediamo certe atrocità ma preferiamo fingere di non vedere, noi che vediamo certe atrocità come sfondo opaco di un’ordinaria quotidianità, senza più indignarci. Eppure questo problema esiste, e ci appartiene. Il ritorno della catarsi nella contemporaneità ha le forme di un crocifisso dorato al collo, il suono di su di noi nemmeno una nuvola o di un gelato al cioccolato che “alla Festa della Madonna non gliela facciamo cantare a Pupo, l’ha scritta Cristiano Malgioglio, ed è un chiaro riferimento a un cazzo”, l’alternanza scenica di un veloce montaggio cinematografico. La pièce si apre con una tetra scenografia: un tavolino azzurro con un alberello di natale che si accende e si spegne ad intermittenza, un chinotto aperto, una radio un po’ retro, dei fazzoletti. Sullo sfondo un corvo poggia le sue esili zampe su una grande bara marrone, mentre un’altra più piccola bianca deve ancora essere sistemata. In primo piano una salma, quella di Ajaaaaaa’, morto suicida. La trafugazione delle salme, il loro occultamento e quindi la necessaria conseguente scomparsa della memoria di quel morto è una delle tematiche che legano l’antica tragedia all’atto di accusa di De Luca. L’offesa al corpo è al centro del palco, è al centro dello spettacolo, sotto i nostri occhi compromessi da quella persiana, un “filtro” che è decisamente cinematografico. In questa prima parte gli sguardi, gli atteggiamenti e le battute decisamente pulp mirano ad affermare una gerarchica virilità dove un ragazzotto di bottega si trova ad essere l’elemento di scherno del branco dei malavitosi. E’ un personaggio caro all’autore: “Questo cazzone sicuramente non è uno stinco di santo, è il classico ragazzotto di bottega che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. E’ quello che ti può capitare stando in Calabria, nemmeno ti rendi conto alle volte di trovarti in un collettivo malavitoso. E una volta che sei lì ti viene proposta della cocaina o di maneggiare un morto e lo fai. Questo perché il male ha una contiguità spaziale in Calabria, spesso viene ammazzato qualcuno che “si trovava lì per caso”, ed è questo che ho cercato di raccontare.” Uomini tutti d’un pezzo, uomini d’onore, macisti ed arroganti, che realmente riconosciamo nel modo in cui De Luca ce li presenta, uomini anche con le loro tenerezze e fragilità. Agamennone stringe le mani sul volto del fratello Menelao per tranquillizzarlo e ribadirgli la forza del loro legame di sangue, Aiace si siede in braccio al suo prigioniero che soffoca dentro metri di Domopack raccontandogli la triste storia del suo diciottesimo compleanno. Nel giorno del suo diciottesimo compleanno Aiace aspettava con ansia un regalo dalla madre, la quale lo liquidò con qualche soldo. “Mammaaa abbiamo appena rapinato una banca che diavolo me ne faccio dei soldi? Io volevo un regaloooo, qualsiasi cosa, anche un pigiama visto che dormo in mutande, ma un regalooo”. In quel pigiama, in quel racconto, la genesi di un malavitoso. Lo spettacolo si chiude con il rapimento della salma da parte di Menelao e Agamennone, un Ulisse che fuma impassibile e che scruta la platea in un ennesimo atto di accusa e le note di scherzose di un mondo d’amore. Alla domanda su quali siano i prossimi progetti in cantiere della compagnia, De Luca risponde: “La compagnia sta lavorando su uno spettacolo (“La Borto”) di Saverio La Ruina che ha come tema l’aborto. Non sarà uno spettacolo prettamente “civile”. Racconta le difficoltà di un mondo femminile in un mondo dove le dinamiche sono principalmente maschiliste. La pièce debutterà al Teatro India di Roma a Novembre. Inoltre “U Tingiutu: un Aiace in Calabria” continuerà a girare, per il momento abbiamo fatto solo cinque repliche.” Un caloroso invito ad andare a vedere la prossima.
Calabria Ora – Giorgio Massacra – 17/06/2009
da Primavera dei teatri 2009 […] Mentre l’uso del dialetto ha una ben diversa funzione del “U Tingiutu. Un Aiace di Calabria”, scritto e diretto da Dario De Luca, di Scena Verticale. Si tratta di una traduzione in termini mafiosi delle vicende dell’eroe omerico, ovviamente con l’uso della lingua degli uomini d’onore. Una sorta di demisitificazione del mito, delle grandi imprese dei celebrati eroi dell’antichità, visti come uomini di potere, violenti e senza scrupoli, prepotenti e senza remore morali. Un’opera audace e iconoclasta, che può lasciare interdetto il laudator temporis acti, ai cui occhi rischia di apparire sacrlilego ogni tentativo di reinterpretare la storia alla luce della logica eterna degli interessi materiali e del potere politico.
Calabria Ora – Giorgio Franco – 05/06/2009
Devianze, devozioni
La serata del tre giugno a Castrovillari prevedeva in cartellone l’esibizione di Scena Verticale, la Compagnia che gestisce l’intera messa in opera della Rassegna castrovillarese: “U tingiutu”, ideato, scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca, uno dei patron della Kermesse. Avevo avuto modo di assistere allo studio della messa in scena rappresentato al Morelli di Cosenza e mi era sembrato che il lavoro abbisognasse di un’asciugatura, che ne evidenziasse le parti maggiormente significative nella disanima delle devianze. Noto che la parte femminile che rischiava di rendere melodrammatica l’intera vicenda è scomparsa, noto che il tentativo di collegare de terministicamente i fatti calabresi e la tragedia greca ha ceduto ad una dimensione metastorica della tragicità degli eventi, che se rivelano una loro attualità, non devono perdere la carica figurale. Il male, la protervia, la ragione usata come calcolo strategico finalizzato al sopruso e all’arroganza del potere, sono elementi eterni e bene ha fatto Dario De Luca, a mantenere quell’atmosfera di dramma atemporale, cui le Tragedia greca, e Sofocle in particolare, non possono sfuggire. Continuo a nutrire perplessità sull’uso del dialetto, che a mio parere, deve essere aspro, barbarico, quasi incomprensibile, carico e generoso di suoni e lessemi che non possono convivere con intercalari, modi di dire, frasi idiomatiche che a volte sono sfuggiti agli autori nelle stesura del testo. A mo’ di esempio, ma su un altro fronte, avrei optato per Menelà, Ulì, Agamè, Oi Tè, anche con il fine di onorare e completare quei sapidi monologhi in cui i singoli esprimono con candore iconoclasta la loro weltanschaung. Ripeto che ho trovato geniale la scelta dell’ambientazione in una sala mortuaria, non diventata ancora location da “caro estinto”. Auspico che la lettura delle figure mitologiche e la resa artistica che ne hanno realizzato i tragediografi del passato possano alimentare questa contaminatio tra l’ora e l’allora che i teatranti di Scena Verticale hanno avviato. Vale molto di più, ai fini della sedimentazione della coscienza civile antimafiosa, una lettura comparativa del testo classico, anziché le mille carnevalate cui oramai ci hanno abituato le istituzioni, non solo scolastiche. Infine: bene, bravi e ad maiora.
Il Quotidiano della Calabria – Simona Negrelli – 05/06/2009
Aiace, tragedia e malavita Può una tragedia greca essere riscritta come fosse una storia da malavita organizzata? I suoi personaggi trasformarsi in sgherri meschini, balordi e spietati? La sua azione svolgersi in una qualunque provincia calabrese? Secondo Scena Verticale sì, anche perché l’arché, il principio ispiratore, è lo steso onore ofeso che a volte muoveva celebrati guerrieri ed eroi letterari dell’antica Grecia oppure, ancora oggi, rozzi ‘ndranghetisti. Così, l’Aiace di Sofocle, diventa U Tingiutu – Un Aiace di Calabria, ideato, scritto e diretto da Dario De Luca e sulle tavole del Protoconvento Francescano di Castrovillari, mercoledì scorso, lo stesso De Luca, Marco Silani, Ernesto Orrico, Rosario Mastrota e Fabio Pellicori strappano applausi a scena aperta col loro spettacolo presentato in anteprima nazionale a Primavera dei Teatri. […] Il sipario si apre su un’agenzia di pompe funebri, quartier generale della cosca, dove insieme ai cadaveri si preparano panetti di droga, dove gerarchie e soprusi si sposano alla paura e all’omertà. Il dialetto calabrese rende bene la crudezza della scena, la sfrontatezza dei volti. Tutto si svolge in una quotidianità aberrante, frivolezza e morte accostate con nonchalance. Fino al colpo di scena, gli spari in sala e un’esecuzione in stile mafioso. I titolari dell’agenzia di pompe funebri rimangono a terra e l’effetto è sicuramente cinematografico. Proprio sullo stile da celluloide è giocato tutto lo spettacolo. La scena cambia e Aiace è di fronte a Ulisse, l’amico di un tempo che gli ha sottratto l’onore delle armi alla morte di Achille, diventando capobastone al suo posto. Aiace ha compiuto l’esecuzione e ora tortura Ulisse, in un crescendo di azione emotiva che arriva al climax, tocca il suo apice, suicidandosi, visto che ormai è un condannato a morte dalla malavita, un “tingiutu”, appunto. E il monologo di Aiace – De Luca, oltre alla prova di un bravo attore, è anche lo spaccato di una società degradata, dove la miseria umana è il pane quotidiano, la violenza è scambiata per coraggio e la vigliaccheria per rispetto. La tragedia si conclude con la disputa tra Menelao, Agamennone e Teucro sulla sepoltura di Aiace, con una struttura circolare, tornando al punto di partenza.
Calabria Ora – Domenico Iozzo – 15/01/2010
“U Tingiutu”, mondo senza sena redenzione Sulla scena – fin dall’incipit fulminante che ricorda gli effetti autodistruttivi del lusso nella Napoli neomelodica di “Gomorra” – si alternano risate stranianti e tocchi di ironia demenziale a fare da contrappunto ai silenzi disarmanti di un intreccio narrativo volto a confondere lo sguardo degli spettatori con le parole più che con le azioni. C’è il culto della famiglia e l’inevitabile superbia del potere dietro alle “faide” dettate da gerarchie crudeli che portano ad eliminare chi ha il “vizio di parlare troppo”. Ancora più strazianti sono le urla di dolore di chi sarà costretto a riscoprirsi carnefice dopo aver annusato la paura della morte. È il destino che sembra voler accompagnare gli uomini della nostra terra, costretti a vivere sotto il peso dell’onore e del rispetto sempre con “un prezzo da pagare”. Spazi angusti ospitano il piccolo thriller di tradimenti e riscatti in cui Dario De Luca, Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori e Marco Silani si distinguono come perfetti interpreti delle dinamiche della violenza che hanno nel dialetto il loro ideale mezzo espressivo. In “U tingiutu” non c’è redenzione ma il senso di impotenza sembra suggerirci l’importanza di un modello di educazione alternativo.
Il tamburo di Kattrin – Silvia Gatto – 17/06/2009
Mala Magna Grecia
Aiace, Achille, Agamennone, Ulisse: questi i nomi dei protagonisti di U Tingiutu, di Scena Verticale, spettacolo andato in scena ieri sera al Bastione Alicorno in prima nazionale. Ma nessuna tragedia greca in versi accademicamente recitati: Dario de Luca, ideatore, drammaturgo e regista del lavoro, scaraventa l’antico mito Sofocleo nella Calabria corrosa dalla ‘ndrangheta. Sangue, onore e cocaina sono i veri protagonisti. Sgarri e vendette si susseguono all’intero di un’agenzia di pompe funebri che è anche sede di una cosca mafiosa. La particolare costruzione drammaturgica, fortemente cinematografica – con un inizio in flashback e alcuni salti temporali, accattiva il pubblico che – nonostante alcune difficoltà di incomprensione per l’uso del dialetto calabro – segue con trasporto questa ennesima storia di malavita. Pur, intravedendola, perché, esclusa la prima scena, la quarta parete è chiusa per tutto lo spettacolo da tende veneziane. Questa tragedia moderna è sotto gli occhi di tutti ogni giorno, ma in molti devono, o vogliono, far finta di non vedere. E così lo spettatore si ritrova come ‘al sicuro’ aldilà delle tende, lontano da quel mondo che non gli appartiene, ma non può non lasciarsi coinvolgere emotivamente. Forse un assaggio di quella maledizione che, scrive De Luca, «in Calabria si chiama “contiguità”. Quella cosa terribile che costringe onesti e disonesti, mafiosi e non mafiosi a vivere fianco a fianco». In questo racconto, oltre alle efficaci musiche originali composte da Gianfranco De Franco e Gennaro “Mandara” de Rosa, una radio accompagna le truci vicende, cantando canzonette di Pupo, Vasco e Morandi. E proprio le prime battute di una canzone di Morandi – Un’anno d’amore – assumono improvvisamente, sull’immagine della strage finale, un significato altro, che spiazza: «uno: non tradirli mai, han fede in te» – come se fosse il primo, sacro, comandamento dei clan mafiosi. Grazie anche ai suoi colleghi di scena (Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori, Marco Silani) – tutti decisamente all’altezza dell’impresa con un’interpretazione autentica, De Luca costruisce, con una regia semplice e genuina, quasi un film neorelista. Un bel film, che punta la macchina da presa negli angoli più bui della terra calabra, mettendo a fuoco delle verità scomode che tutti sanno e tacciono. La tragedia, così, si svuota degli eroi per narrare le vicende di una Magna Grecia tristemente più attuale, vivente, straziata da omini che non hanno decisamente nulla di eroico.
Teatri Milano – Silvia Pizzi – 31/01/2010
Il mito della lotta per l’onore secondo Scena Verticale […] Questo lavoro, che Scena Verticale ha presentato al Teatro I di Milano, parte da una vicenda inventata, che è la ricomposizione di un cadavere all’interno di un’agenzia di pompe funebri, per poi svilupparsi passo passo secondo la trama dell’Aiace, ma seguendo una sua personalissima struttura, che non è una semplice intuizione registica di De Luca, ma una precisa scelta operata già a livello drammaturgico e che consiste nello smontare la storia in “momenti” significativi (la tortura, la follia, il conflitto, la vendetta) per rimontarli con una tecnica quasi cinematografica, in un ordine che va ad amplificare i temi centrali dell’onore/disonore, della violenza e dell’ingiuria del cadavere. Una sorta di “flash” alla Pulp Fiction che si svolgono tutti all’interno dello stesso ambiente e che, tra minacce di coltelli, lobi staccati a morsi, morti ammazzati, spari che scoppiano e fanno saltare sulla sedia… vengono buttati con la forza di schiaffi in pasto allo spettatore a cui rimane solo qualche sporadico secondo di dissolvenza tra una situazione e l’altra per tirare un sospiro di sollievo. Ma soprattutto tirare le somme. Perché la struttura accattivante non è certo di immediata né semplice comprensione. La scrittura di De Luca è l’evidente frutto di un’esperienza che non si ferma alla drammaturgia, ma spazia anche in ambito registico e recitativo, perché tiene conto di una serie di fattori estremamente funzionali alla scena (come appunto la struttura stessa) che contribuiscono ad arricchire il risultato finale. Interessante, a livello registico, l’intuizione della veneziana, che ad un tratto viene abbassata in proscenio, lasciando solo intravedere ciò che avviene in scena. Molto buona anche la performance degli attori, che suona spesso come un ulteriore rimando al linguaggio cinematografico, con dialoghi serrati e dal sapore forzatamente gagstariano.
Persincasa.it – Francesca Brancaccio – 30/01/2010
[…] Una sola scena, impietosamente aperta davanti agli spettatori, diventa teatro di più delitti; la stanza dove i morti vengono preparati alla loro ultima comparsa in pubblico è la trappola in cui i vivi sono torturati e uccisi. Due bare: una grossa, imponente e pesante; l’altra piccola, bianca, morbida e quasi dolce. Un corvo impagliato, un tavolo di metallo, una radio e un albero di Natale con tanto di lucine colorate intermittenti. Gli attori, tutti uomini, si muovono, gesticolano, ridono, più spesso urlano, si insultano, si minacciano e, quando è necessario, sparano, con un’autenticità fatta di sudore ed espressioni gergali. Allo spettatore non si risparmia niente, nessun orrore, nessuna delusione. Tutto è così reale che può essere accettato solo se visto, o meglio spiato, attraverso le fessure delle veneziane abbassate, grazie a un’efficace intuizione, tra il palco e la platea. Gradualmente, il tragico è svelato. Le scene, senza continuità temporale, cinematograficamente intervallate da transizioni di buio, trasformano la piccola bara immacolata in un nascondiglio per le buste di coca, le catenine d’oro in un segno di appartenenza, la già lugubre stanza in un covo di mafiosi. […] Freneticamente la vicenda procede, si svolge, la storia acquista chiarezza e profondità, i simboli si accumulano, i personaggi in carne e ossa sono sostituiti da beffardi cadaveri di cartapesta, la tensione sale e poi si scioglie, così che il finale a sorpresa giocato da De Luca coglie pienamente il segno. La storia è sempre la stessa, è un gatto che si mangia la coda, è una scena che si ripete uguale, e mentre la voce di Gianni Morandi canta rassicurante e gli attori si inchinano, arriva l’agghiacciante consapevolezza che noi, in ogni caso, siamo i voyeur immobili dall’altra parte delle veneziane.
la Riviera – Katia Colica – 30/08/2009
Aiace si tinge di ‘ndrangheta
[…] U Tingiutu – Un Aiace di Calabria, una piece teatrale figlia di Dario De Luca che la concepisce, la crea e la dirige in una ricostruzione scenica dove egli stesso assieme a Rosario Mastrota, Ernesto Orrico, Fabio Pellicori e Marco Silani, mette in atto con una forza davvero epica, ciò che ha da sempre maggiormente estorto la quiete all’umano: lo sgarro. E lo fa attraverso una forma narrativa dalla sembianza più cinematografica che teatrale: i tempi serrati, i cambi di scena repentini, le musiche di Gianfranco De Franco e Gennaro de Rosa, permettono un ritmo che inchioda lo spettatore al gioco sporco del testimone in cui diviene quasi complice inerme di quegli eroi del niente, di quelle divinità all’incontrario eppure presenti e vivi attraverso i loro riti inquietanti. […] Uno spaccato della malavita organizzata che parte con un ghigno feroce per passare alla ferocia più cristallina e consapevole. E scorrendo tra i corridoi della suggestione, non risparmia neanche gli spettatori che si alzano, al finire dell’ultima scena, accompagnati oltre che da stati d’animo fortemente minati, anche dalle note della celebre canzone di Gianni Morandi “Un mondo d’amore”, ma che nel contesto assume un senso tanto inatteso quanto agghiacciante: “Uno non tradirli mai, hanno fede in te. Due: non li deludere, credono in te”, recita il testo prendendo in carico significati chiaramente arroganti mentre accompagna la strage finale e diventa al contempo una sorta di precetto mafioso. La scena quindi, toglie le maschere agli eroi che si rivelano finalmente in tutta la loro pochezza. Lasciando in bocca allo spettatore il sapore di una realtà quasi senza via d’uscita, mai vinta perché raramente combattuta; e che soprattutto continua a controllare, attraverso le sue ancestrali leggi d’onore, il corso delle nostre vite, per quanto protette da una simbolica tenda veneziana.
dal blog di Primavera dei Teatri – Celeste Bellofiore & Elisabetta Reale – 04/06/2009
Gli eroi greci parlano calabrese I protagonisti portano i nomi degli eroi greci, ma Achille, Menelao, Agamennone sono uomini della mala calabrese. Andato in scena in anteprima nazionale nell’ambito del festival “Primavera dei Teatri”, U Tingiutu. Un Aiace di Calabria, prende le mosse dalla tragedia antica per distaccarsene completamente, utilizzandola solamente come pretesto per raccontare una storia di crudele contemporaneità… Lo spettacolo, finalista al “Premio Riccione”, è scritto e diretto dal co-direttore artistico di Scena Verticale, Dario De Luca…Una narrazione che si sviluppa su continui flash back, come fosse un film, un racconto frammentato, dove i destini dei protagonisti si scontrano risolvendo dubbi e domande solo nel finale. La prima scena, solo apparentemente comica, è carica di dramma – siamo in una ditta di pompe funebri, un cadavere sul tavolo, una piccola bara bianca aperta e dei truccatori di salme dialogano tra loro; è questo il quartier generale del clan, dove vengono ideati e compiuti spietati piani – e si chiude improvvisamente con degli spari. A questo scenario di sangue assistiamo attraverso una serie di veneziane calate dal boccascena, che immettono in una condizione voyeristica lo spettatore, nascosto nel buio della platea, ma che allo stesso tempo esce allo scoperto con fugaci risate mosse dalla comicità violenta espressa dai corpi in scena, dei morti che camminano, segnati da un destino che si lega inevitabilmente ai riti di affiliazione e ai patti di sangue. Dopo deflagra la violenza, cruda, prepotente, lo scontro tra le famiglie, fatto di odio, rancori, vendette. Tutto è reso ancora più vivo e crudele dall’uso del dialetto, la lingua degli uomini della mala, calabrese che varia dalle forme meno marcate dei giovani affiliati a quella più arcaica di Aiace, vecchio “uomo d’onore” – nel finale, prima di uccidersi, è lui a dire che nella vita chi sbaglia, deve pagare, non importa come – . Una lingua che porta con sé il mistero del detto e non detto, la forza espressiva di parole e di gestualità connaturate nella cultura meridionale, dove il termine redenzione viene risucchiato e intrappolato in quel vortice di sangue alimentato dalle logiche della criminalità.